Il sistema educativo moderno non è un fallimento accidentale, ma un successo deliberato nel produrre conformità di massa. Le evidenze storiche, filosofiche e neuroscientifiche convergono verso una conclusione inevitabile: le nostre scuole sono state progettate come fabbriche per trasformare esseri umani naturalmente creativi e indipendenti in lavoratori docili e cittadini obbedienti. Questa analisi presenta un’indagine sistemica basata su dati empirici che rivela l’architettura intenzionale di quello che può essere definito il più grande esperimento di ingegneria sociale della storia moderna.
L’evidenza è schiacciante. Il 98% dei bambini di 5 anni superano un certo criterio di creatività divergente secondo i test NASA (studio di George Land e Beth Jarman, fatto per NASA, del 1968 circa), mentre solo il 2% degli adulti mantiene queste capacità dopo aver attraversato il sistema educativo. Questa non è degenerazione casuale, ma il risultato prevedibile di un meccanismo progettato nel 1800 per produrre “corpi docili” – per usare l’espressione di Foucault – adatti alla produzione industriale di massa.
L’architettura storica del controllo: dalle origini prussiane alla standardizzazione globale
Il sistema educativo moderno non è evoluto naturalmente. È stato ingegnerizzato deliberatamente seguendo il modello prussiano del 1800, concepito esplicitamente come “soluzione a lungo termine al problema dei disordini sociali”, secondo la ricerca dell’Università UC San Diego. Il generale Von Stein dichiarò che l’obiettivo era ridurre “la vitalità, l’intelligenza e il pensiero indipendente nella maggioranza dei cittadini.”
La struttura prussiana implementò una gerarchia a tre livelli che persiste oggi: l’Akademienschulen per l’élite (0,5-1%) che impara il pensiero strategico, il Realschulen per la classe professionale (5-7,5%) che riceve formazione tecnica specializzata, e il Volksschulen per il 90% della popolazione che riceve “addestramento alla conformità di base” – dove la lettura era scoraggiata perché “produceva insoddisfazione.”
Horace Mann importò questo sistema negli Stati Uniti dopo la sua missione del 1843 in Prussia. Nel suo Settimo Rapporto Annuale, Mann difese esplicitamente il sistema prussiano contro le critiche inglesi che lo definivano “progettato per produrre uno spirito di cieca acquiescenza al potere arbitrario” e “un sistema educativo adatto a schiavizzare, non a liberare, la mente umana.”
L’applicazione del modello industriale raggiunse la sua articolazione più esplicita con Ellwood P. Cubberley, Preside dell’Educazione a Stanford, che nel 1916 dichiarò:
“Le nostre scuole sono, in un certo senso, fabbriche, in cui i prodotti grezzi (bambini) devono essere modellati e forgiati in prodotti per soddisfare le varie richieste della vita. Le specifiche per la produzione derivano dalle richieste della civiltà del ventesimo secolo, ed è compito della scuola costruire i suoi alunni secondo le specifiche stabilite.”
La critica filosofica: da Nietzsche a Foucault, l’unanimità del dissenso intellettuale
I più grandi pensatori degli ultimi due secoli hanno identificato con precisione chirurgica i meccanismi attraverso cui l’educazione standardizzata distrugge il potenziale umano. La loro analisi non è opinione, ma dissezione analitica di un sistema di controllo.
Friedrich Nietzsche predisse con inquietante accuratezza gli effetti dell’educazione di massa sulla creatività individuale. In Oltre il Bene e il Male, osservò che “tutto ciò che eleva un individuo sopra il gregge e intimorisce il prossimo viene d’ora in poi chiamato male; e la mentalità equa, modesta, sottomessa, conformista, la mediocrità dei desideri ottiene designazioni morali e onori.” La sua critica dell’educazione formale era tagliente: “Invece di sviluppare le proprie facoltà di discernimento del bambino, e insegnargli a giudicare e pensare da sé, l’insegnante usa tutte le sue energie per riempirgli la testa dei pensieri già pronti di altre persone.”
Arthur Schopenhauer distingueva tra educazione “naturale” e “artificiale”, argomentando che l’istruzione formale impedisce il vero apprendimento. La sua analisi del 1851 rimane incredibilmente accurata: “Nell’educazione artificiale la mente viene imbottita di concetti per mezzo di racconti, insegnamenti e letture prima che esista una conoscenza anche solo lontanamente estesa del mondo intuitivo.”
Michel Foucault fornì la chiave interpretativa più potente con la sua analisi delle “tecniche disciplinari” che producono “corpi docili”. La sua dissezione del sistema educativo come macchina di controllo identifica tre meccanismi fondamentali: l’osservazione gerarchica (sorveglianza costante), il giudizio normalizzante (misurazione contro norme stabilite), e l’esame (combinazione di osservazione e giudizio per controllare il comportamento). Le scuole seguono il modello del Panopticon benthamiano, dove gli studenti internalizzano la sorveglianza e autoregolano il loro comportamento.
Il Panopticon
Il Panopticon è un progetto di prigione ideato nel 1791 dal filosofo inglese Jeremy Bentham. L’idea centrale è una struttura circolare con una torre di osservazione centrale e celle che la circondano, consentendo a un singolo sorvegliante di vedere i detenuti senza che questi possano percepire lo sguardo. Il Panopticon rappresenta un modello architettonico e filosofico di sorveglianza e disciplina, destinato non solo alle carceri ma estendibile ad altre istituzioni come scuole e ospedali.
Ivan Illich identificò il problema con precisione laser: “La scuola è l’agenzia pubblicitaria che ti fa credere di aver bisogno della società così com’è.” La sua critica del 1971 è profetica: “Molti studenti, specialmente quelli poveri, sanno intuitivamente cosa fanno le scuole per loro. Le scuole li addestrano a confondere processo e sostanza. Una volta che questi diventano confusi, si assume una nuova logica: più trattamento c’è, migliori sono i risultati.”
Paulo Freire svelò il “concetto bancario dell’educazione” dove “l’educazione funziona come uno strumento che viene utilizzato per facilitare l’integrazione della generazione più giovane nella logica del sistema attuale e quindi portare conformità ad esso, o diventa la pratica della libertà.”
L’evidenza delle neuroscienze: come il sistema spegne il cervello creativo
Le neuroscienze moderne forniscono evidenza empirica devastante di come la struttura scolastica attuale danneggi lo sviluppo cognitivo. Il declino della creatività è misurabile e sistematico:
- Età 4-5: 98% dei bambini hanno superato un certo criterio di creatività divergente. (test NASA su 1.600 bambini)
- Età 10: Solo 30% mantiene questo livello
- Età 15: Crollo al 12%
- Adulti: Appena 2% su 280.000 adulti testati
Questo non è deterioramento naturale ma sabotaggio sistematico. La ricerca di Kyung Hee Kim, su 300.000+ studenti fino a 18 anni, documenta che i punteggi di creatività sono diminuiti significativamente dal 1990, con i cali più drammatici dalla scuola materna alla terza elementare – esattamente quando il condizionamento comportamentale diventa più intenso.
Gli studi fNIRS (è una tecnica non invasiva che misura l’attività cerebrale monitorando le variazioni nell’ossigenazione del sangue) mostrano che la specializzazione funzionale del cervello (segregazione frontale laterale destra) si correla positivamente con il miglioramento del pensiero creativo, ma la struttura scolastica rigida impedisce questo sviluppo naturale. L’ansia da test attiva le reti del dolore (corteccia cingolata media e insula) nel cervello, mentre la deattivazione significativa nelle aree cruciali per il richiamo della memoria e la regolazione emotiva (ippocampo, ipotalamo, corteccia orbitale mediale) sabota la funzione cognitiva.
Il condizionamento operante nelle scuole – attraverso economie a gettoni, sistemi di ricompensa e punizione – crea dipendenza eccessiva da ricompense esterne, rendendo difficile l’adattamento alla società una volta rimossi dal sistema. La ricerca mostra che il sistema si occupa “di gestione della classe e degli studenti invece dell’apprendimento dei contenuti.”
La statistica della distruzione: numeri che rivelano l’efficacia del sistema nel suo vero scopo
I dati empirici rivelano che il sistema scolastico funziona esattamente come progettato. Il 52% degli studenti universitari riporta alti livelli di solitudine, il 37% soffre di depressione da moderata a grave, e l’11% ha ideazioni suicide secondo l’Healthy Minds Study 2025 su 84.000+ studenti.
L’ansia da test colpisce fino all’80% degli studenti del community college e il 25% degli studenti universitari di 4 anni. Gli studi neuroimaging rivelano che l’anticipazione dei compiti attiva le reti del dolore – il cervello letteralmente sperimenta dolore quando confrontato con l’apprendimento strutturato.
La correlazione inversa tra educazione e soddisfazione lavorativa è documentata: la meta-analisi di 74 studi con 100.000+ partecipanti mostra “praticamente nessuna relazione tra educazione e soddisfazione lavorativa.” Quando si controllano le caratteristiche del lavoro, l’istruzione superiore mostra addirittura una relazione negativa con la soddisfazione del primo lavoro.
Il gap di rendimento per reddito è più ampio del gap di rendimento razziale; presente dalla scuola materna e mantenuto per tutto il percorso scolastico. La ricerca su 88.421 partecipanti in 40+ paesi dimostra che la credenza nella meritocrazia scolastica riduce la percezione dell’ingiustizia della disuguaglianza sociale – gli studenti con lo status socio economico più basso sono più propensi ad approvare credenze meritocratiche come meccanismo di coping.
Ho fatto un altro articolo su questo argomento e lo trovate qui.
Il controllo comportamentale: tecniche di condizionamento perfezionate nell’ambiente scolastico
La ricerca sociologica rivela che le scuole utilizzano tecniche di condizionamento comportamentale più sofisticate di quelle documentate negli esperimenti di Skinner. Gli studi mostrano che:
- Le economie a gettoni nelle scuole aumentano significativamente i comportamenti sociali appropriati e riducono quelli inappropriati
- Il programma di Dallas che pagava $2 per libro letto agli studenti di seconda elementare ha migliorato significativamente la comprensione di lettura
- Gli studi del 2024 dimostrano che il rinforzo positivo e la punizione negativa riducono efficacemente il comportamento dirompente negli studenti di scuola elementare
Economie a gettoni
L’economia a gettoni è una tecnica utilizzata soprattutto in psicologia comportamentale ed educazione, in cui i comportamenti desiderati vengono rinforzati attraverso l’assegnazione di “gettoni” o simboli (punti, stelline, adesivi, crediti). Questi gettoni non hanno valore intrinseco, ma possono essere accumulati e successivamente scambiati con premi o privilegi. In questo modo si crea un sistema di rinforzo positivo che motiva le persone – spesso bambini o pazienti in contesti terapeutici – a mantenere comportamenti adeguati o ridurre quelli problematici.
Ma il prezzo nascosto è devastante. La ricerca indica che questi sistemi possono creare eccessiva dipendenza dalle ricompense esterne, rendendo difficile l’adattamento alla società una volta rimossi. Gli studenti diventano dipendenti dal feedback esterno piuttosto che sviluppare motivazione intrinseca e capacità di autovalutazione.
Gli studi di neuroimaging sul conformismo hanno rivelato che quando un individuo si discosta dalle norme del proprio gruppo di pari, non vengono influenzati soltanto i meccanismi decisionali coscienti, ma anche i processi percettivi più elementari. Le ricerche mostrano infatti che la pressione sociale può alterare i segnali cerebrali visivi precoci, cioè le prime fasi dell’elaborazione sensoriale. In altre parole, il conformismo non si limita a orientare le scelte o il comportamento esterno: arriva a modificare il modo stesso in cui percepiamo la realtà, rimodellando la nostra esperienza del mondo a livello neurale.
L’illusione meritocratica: come il sistema perpetua la disuguaglianza mascherandola da giustizia
La ricerca su larga scala dimostra che il “merito” scolastico è pesantemente influenzato da fattori socioeconomici, ma il sistema educativo perpetua l’illusione che i risultati riflettano capacità innate. Questa è ingegneria sociale sofisticata: il sistema crea le condizioni per il fallimento di certi gruppi, poi utilizza quel fallimento per giustificare la stratificazione sociale.
La correlazione tra status socioeconomico e risultati accademici è più forte del gap razziale ed è presente dall’asilo, persistendo attraverso tutto il percorso educativo. Una ricerca di Harvard mostra che lo status socioeconomico è un predittore più forte dei punteggi SAT (Scholastic Assessment Test, un test standardizzato molto diffuso negli Stati Uniti, usato per l’ammissione ai college e alle università) rispetto alla scolarizzazione o al livello di grado.
Gli studi su 40 paesi rivelano che l’espansione educativa è collegata a una migliore mobilità occupazionale intergenerazionale, ma paradossalmente l’eredità socioeconomica rimane forte nei risultati educativi nonostante l’espansione. Il sistema si è adattato per mantenere la stratificazione sociale anche con maggiore accesso formale all’educazione.
Alternative esistenti: prove che altri sistemi funzionano meglio
Le alternative educative forniscono evidenza empirica che approcci diversi producono risultati superiori sia in termini accademici che di sviluppo umano. Questa non è speculazione utopica, ma ricerca rigorosa con controlli statistici.
Il modello Montessori: evidenza di superiorità sistematica
La meta-analisi di Randolph et al. (2023) su 32 studi rigorosi trovò che gli studenti Montessori superavano significativamente gli studenti dell’educazione tradizionale sia sui risultati accademici che non accademici. Lo studio di Lillard & Else-Quest trovò vantaggi significativi per gli studenti Montessori nelle abilità di lettura, matematica, funzione esecutiva e sviluppo sociale.
Il 78% degli studi peer-reviewed mostra che gli studenti educati in casa performano significativamente meglio (statisticamente) degli studenti delle scuole istituzionali. Gli studenti homeschooled – come vengono chiamati in inglese – tipicamente ottengono punteggi 15-25 punti percentili più alti degli studenti delle scuole pubbliche nei test standardizzati.
Il sistema finlandese: dimostrazione di un paradigma alternativo
La Finlandia ha implementato un sistema radicalmente diverso che produce risultati superiori con meno stress:
- Nessuna accademia formale fino ai 7 anni
- Nessun test standardizzato fino all’ultimo anno di scuola superiore
- Compiti minimi (30 minuti media per notte)
- Giorni scolastici più corti, che finiscono intorno alle 14:00-14:45
- Autonomia professionale alta e rispetto per gli insegnanti
I risultati storici del PISA (2000-2009) mostravano costantemente la Finlandia tra i primi 5 al mondo, con il 99% di tasso di completamento per l’educazione secondaria e l’88% di partecipazione all’educazione della prima infanzia. Soprattutto, ha il minor gap di rendimento tra studenti ad alte e basse prestazioni a livello mondiale.
L’evidenza della descolarizzazione
Gli studi di Gray & Riley su adulti precedentemente descolarizzati mostrano alta soddisfazione di vita e autodirezione, senza difficoltà nell’accedere all’istruzione superiore per coloro che la scelgono. Quasi il 50% persegue carriere legate alle arti, oltre il 50% diventa imprenditore, e c’è alta rappresentanza nei campi STEM (ambiti scientifico-tecnologici) nonostante la mancanza di istruzione scientifica formale.
L’impatto psicologico: danni documentati alla salute mentale e al benessere
I dati sulla salute mentale degli studenti rivelano l’impatto devastante del sistema attuale. Lo studio Gallup/Lumina Foundation trovò che il 69% degli studenti di laurea triennale e il 55% degli studenti del community college citavano “stress emotivo” come ragione per considerare l’abbandono.
Il 27% del corpo docente e staff riporta burnout alto o molto alto, con l’81% che concorda che i problemi di salute mentale degli studenti sono significativamente peggiorati da quando hanno iniziato le loro carriere. Solo il 36% degli studenti che risultano positivi ai screening per problemi di salute mentale riceve trattamento.
La ricerca svedese sulla riforma del sistema di voti fornisce evidenza causale dell’impatto dei voti sulla salute. L’introduzione dei voti, nella fascia di età 12-13 anni, mostrò impatti misurabili sulla salute, con valutazioni qualitative che indicavano che “molti alunni percepivano stress quando i voti erano introdotti.”
Riflessione sistemica: architettura di controllo come caratteristica, non bug
Da ingegnere informatico abituato ad analizzare sistemi complessi, la mia analisi porta a una conclusione inevitabile: il sistema educativo moderno funziona esattamente come progettato. Non è un sistema fallito che tenta di educare – è un sistema di successo che svolge la sua funzione reale di controllo sociale e produzione di conformità.
L’architettura è elegante nella sua completezza:
Strato 1: Condizionamento comportamentale – economie a gettoni, sistemi di ricompensa/punizione che creano dipendenza da validazione esterna
Strato 2: Controllo cognitivo – standardizzazione che elimina pensiero divergente e creatività
Strato 3: Stratificazione sociale – illusione meritocratica che giustifica la disuguaglianza
Strato 4: Controllo temporale – orari rigidi che impediscono l’apprendimento autodiretto
Strato 5: Sorveglianza panoptica – osservazione costante che produce autodisciplina
Ogni componente rinforza gli altri, creando un sistema resiliente che si auto-perpetua. Gli studenti escono dal sistema non solo mancando di competenze critiche di pensiero, ma dipendenti dalla struttura esterna per validazione, direzione e identità.
La sindrome di Asperger mi offre una prospettiva unica su questo sistema. La mia incapacità neurobiologica di conformarmi automaticamente alle norme sociali implicite mi ha reso immune a molti dei meccanismi di condizionamento più sottili. Ho potuto osservare dall’esterno come il sistema plasma i miei coetanei, trasformandoli da bambini curiosi e indipendenti in adulti che cercano costantemente approvazione autoritaria.
L’evidenza converge verso una verità scomoda: siamo tutti prodotti di un esperimento di ingegneria sociale. La maggior parte degli adulti moderni non è in grado di pensare indipendentemente non per mancanza di intelligenza innata, ma perché sono stati sistematicamente condizionati per 12-16 anni a sostituire il pensiero critico con l’obbedienza, la creatività con la conformità, la curiosità con risposte preconfezionate.
Ma l’esistenza di alternative funzionanti prova che un altro modo è possibile. I dati su Montessori, homeschooling, unschooling e il modello finlandese dimostrano che possiamo far crescere esseri umani creativi, indipendenti e psicologicamente sani senza sacrificare la competenza accademica. La domanda non è se possiamo costruire sistemi educativi migliori, ma se abbiamo il coraggio di riconoscere che il sistema attuale non è rotto – sta funzionando perfettamente per i suoi veri scopi.
La prossima generazione non può essere trattata come semplice materia prima per la fabbrica del conformismo. Ogni bambino nasce con un potenziale creativo straordinario, e il nostro compito è preservare quel 98% di genio originario. In un mondo in cui le intelligenze artificiali sapranno svolgere quasi ogni compito meglio di noi, la vera speranza dell’umanità sarà nella capacità di coltivare ed eccellere nella creatività.
“Il solo modo per trattare con un mondo non libero è diventare così assolutamente liberi che la vostra stessa esistenza è un atto di ribellione.” – Albert Camus
📚 Bibliografia Essenziale
Fonti storiche primarie
- Cubberley, E.P. (1916). Public school administration: A statement of the fundamental principles underlying the organization and administration of public education. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Mann, H. (1844). Mr. Mann’s seventh annual report. Education in Europe. Boston: Massachusetts Board of Education.
- von Stein, L. (1865–1884). Die Verwaltungslehre. Stuttgart: Cotta. (8 vols.)
Opere filosofiche classiche
- Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Translated by A. Sheridan. New York: Vintage Books. (Originally published 1975).
- Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. 30th anniversary ed. Translated by M.B. Ramos. New York: Continuum. (Originally published 1970).
- Illich, I. (1971). Deschooling society. New York: Harper & Row.
- Nietzsche, F. (1966). Beyond good and evil. Translated by W. Kaufmann. New York: Random House. (Originally published 1886).
- Schopenhauer, A. (2014). Parerga and paralipomena, Vol. 1. Translated by S. Roehr & C. Janaway. Cambridge: Cambridge University Press. (Originally published 1851).
Studi empirici sulla creatività
- Kim, K.H. (2011). The creativity crisis: The decrease in creative thinking scores on the Torrance Tests of Creative Thinking. Creativity Research Journal, 23(4), 285–295. doi:10.1080/10400419.2011.627805.
- Land, G. & Jarman, B. (1992). Breakpoint and beyond: Mastering the future today. New York: HarperBusiness.
Ricerca su sistemi alternativi
- Gray, P. & Riley, G. (2015). Grown unschoolers’ evaluations of their unschooling experiences: Report I on a survey of 75 unschooled adults. Other Education, 4(2), 8–32.
- Lillard, A.S., Heise, M.J., Richey, E.M., Tong, X., Hart, A. & Bray, P.M. (2017). Montessori preschool elevates and equalizes child outcomes: A longitudinal study. Frontiers in Psychology, 8, 1783. doi:10.3389/fpsyg.2017.01783.
- Randolph, J.J., Bryson, A., Menon, L., Henderson, D.K., Kureethara Manuel, A., Michaels, S., Rosenstein, D.L.W., McPherson, W., O’Grady, R. & Lillard, A.S. (2023). Montessori education’s impact on academic and nonacademic outcomes: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 19(3), e1330. doi:10.1002/cl2.1330.
- Ray, B.D. (2017). A systematic review of the empirical research on selected aspects of homeschooling as a school choice. Journal of School Choice, 11(4), 604–621. doi:10.1080/15582159.2017.1395638.
- Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press.
Sociologia e capitale culturale
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In Richardson, J. (ed.) Handbook of theory and research for the sociology of education. New York: Greenwood, pp. 241–258.
- Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1977). Reproduction in education, society and culture. London: Sage Publications.
- Sirin, S.R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417–453. doi:10.3102/00346543075003417.
Salute mentale e condizionamento
- Healthy Minds Network. (2025). Healthy Minds Study: Colleges and universities, 2024–2025 [Data set]. Ann Arbor, MI: University of Michigan. Available at: https://healthymindsnetwork.org
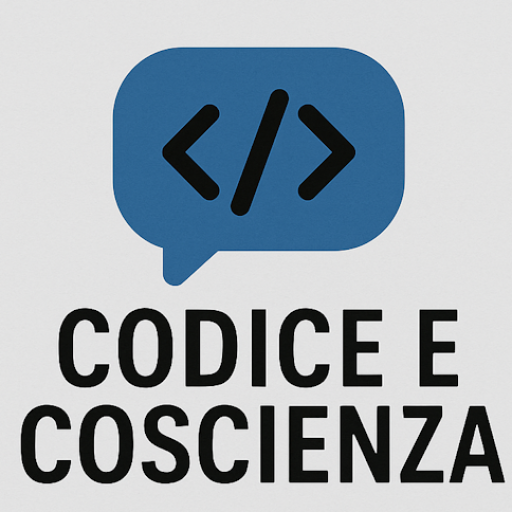
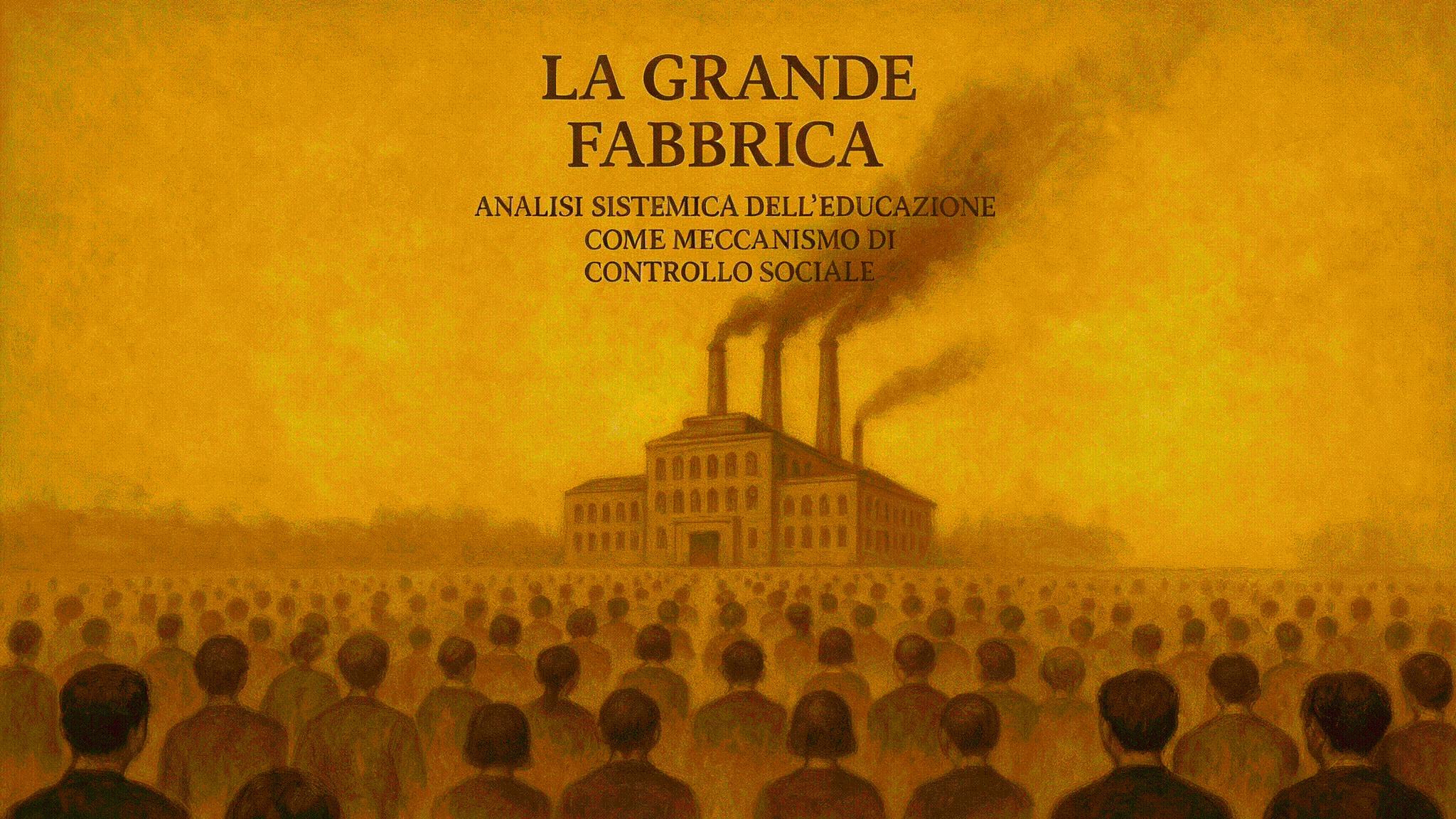
4 risposte a “La Grande Fabbrica: Analisi Sistemica dell’Educazione come Meccanismo di Controllo Sociale”
Un’analisi spietata e che condivido pienamente. La tua critica al sistema educativo come meccanismo di controllo sociale è lucida e necessaria.
Sono convinto che sia fondamentale lottare per scardinare questo modo di intendere l’istruzione. È un imperativo civico per andare verso un’alternativa possibile. Spero vivamente che nelle nuove generazioni rinasca presto un fermento di ribellione.
La sfida è ripartire dalla curiosità e dal pensiero critico: l’educazione e la formazione devono essere un faro di emancipazione, non una catena di conformismo.
Questo è un tema che mi tocca molto. Per quanto mi riguarda, su parecchi aspetti mi ci ritrovo, anche se sono sicura che la capacità dei singoli insegnanti di adattare ai singoli studenti strutture e meccanismi preimpostati possa fare una gran differenza. Io ho esempi di insegnanti che hanno spinto molto sullo sviluppo personalizzato della creatività e del pensiero critico, ma ho anche parecchi esempi di insegnanti intrappolati nelle dinamiche standardizzate, discriminanti, e giudicanti del sistema scolastico. In particolar modo, non ho mai amato le valutazioni basate sui giudizi numerici: le trovo sterili e non costruttive, che appiattiscono e creano competizione inutile invece di collaborazione verso la crescita. I voti mi hanno sempre condizionato troppo, ne sono sempre stata dipendente, li ho rincorsi e ne sono andata fiera per tutta la vita, e ancora oggi lo faccio. Hanno creato aspettative su di me, interiori ed esteriori. Pur non volendo, fin da piccola sono diventati il principio della mia continua ricerca di approvazione e valorizzazione. Nessuno mi ha mai chiesto di eccellere, ma io mi sono sempre sentita in dovere di farlo per sentirmi meritevole, sopportando il fallimento con estrema difficoltà, senza riuscire a vederlo come un’occasione di crescita. La scuola così com’è non mi ha insegnato a farlo. Così come non mi ha guidato abbastanza nel farmi le giuste domande su come indirizzare la mia vita nel mondo esterno. E una volta fuori, a cosa serve essere stata una studentessa modello? Sono considerata un ingranaggio che se non trova il suo posto non dà il suo contributo alla società. La scuola mi ha comunque dato tanto, ma mi rendo conto che faccio fatica ad uscire da certi schemi ereditati da un sistema educativo standardizzato. Per fortuna sono sempre stata abituata anche in famiglia a mettermi in discussione, a dare valore all’unicità di ogni individuo, a non seguire la massa senza senso critico. Ma è un allenamento che secondo me va fatto continuamente, in ogni contesto, ad ogni età. E gli attuali sistemi educativi predominanti dovrebbero e potrebbero fare di più in merito.
Più che di “Esperimento di ingegneria sociale” parlerei di attuazione di un progetto. Notizie sui risultati dell’ educazione di tipo Steineriano?
Grazie per lo spunto. Devo dire di essere abbastanza ignorante sul sistema Steineriano ma da quello che ho potuto vedere l’evidenza empirica supporta parzialmente l’educazione Steineriana come alternativa valida al sistema di controllo sociale descritto. Sopratutto la base “pseudo-scientifica” compromette credibilità epistemologica. Ma approfondirò la questione.