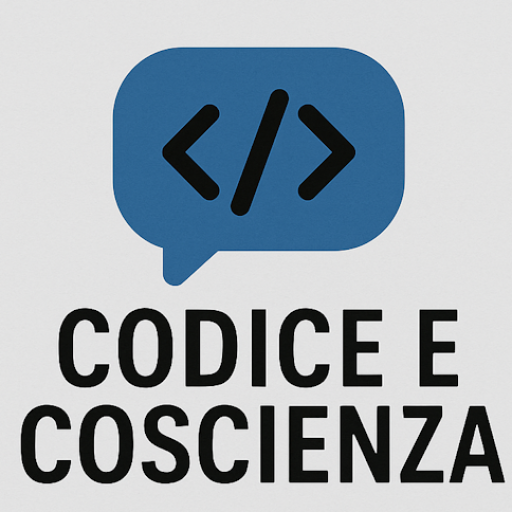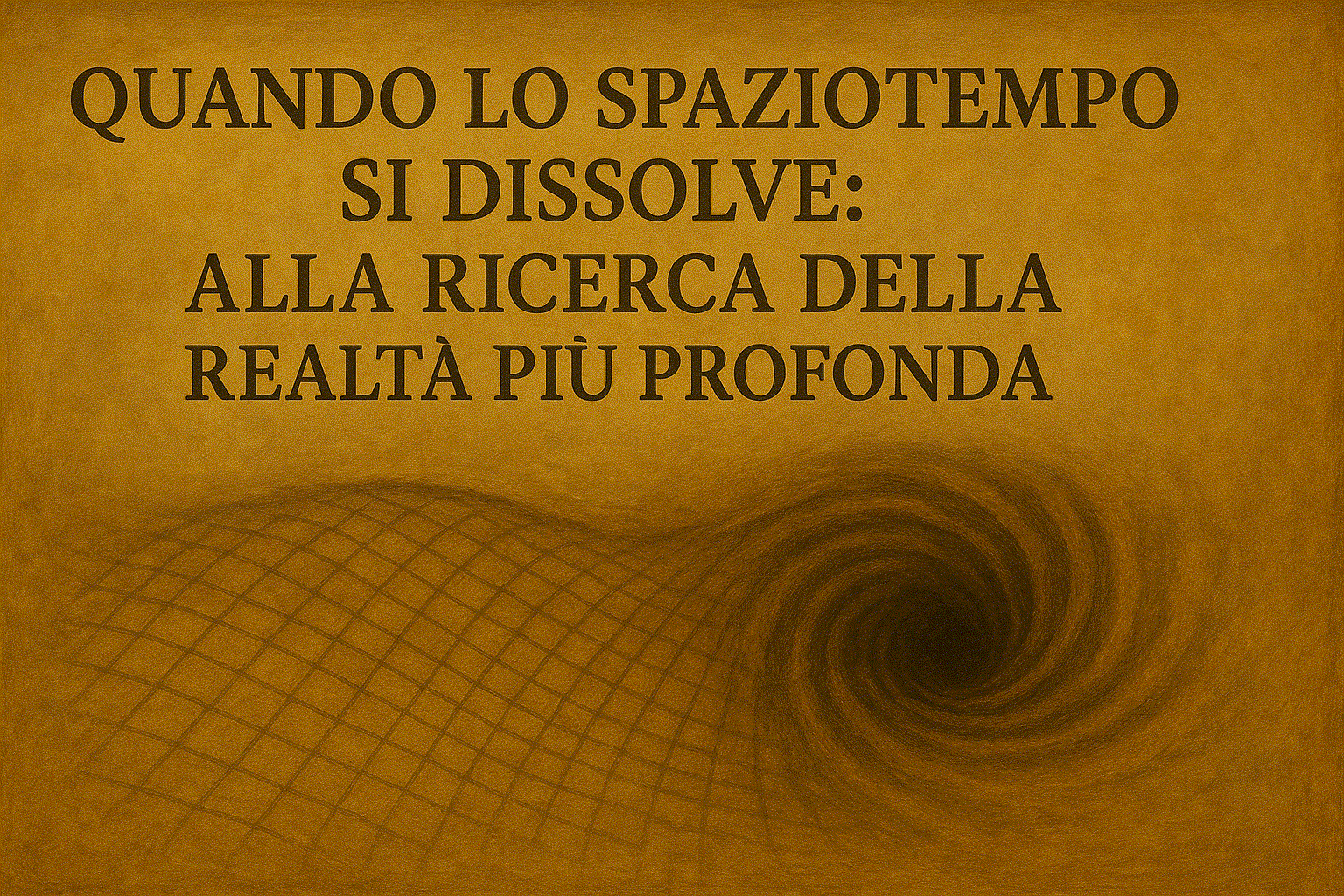Introduzione – il palco invisibile
Da secoli immaginiamo lo spazio e il tempo come il grande palco dell’universo. Stelle, pianeti, esseri viventi recitano la loro parte, ma la scena – fatta di coordinate spaziali e di secondi che scorrono – resta immobile e indipendente. Persino Einstein, che ha unito spazio e tempo in un’unica entità elastica e dinamica, ha comunque mantenuto lo spaziotempo come sfondo fondamentale: esso può piegarsi, dilatarsi, deformarsi, ma c’è sempre.
Eppure, negli ultimi decenni, la fisica teorica sta scardinando questa intuizione. Molti ricercatori oggi ritengono che lo spaziotempo non sia un ingrediente primario della realtà, bensì un fenomeno emergente, come il colore dell’acqua che appare azzurra pur essendo trasparente. In questa prospettiva, ciò che davvero esiste non è la geometria di uno scenario cosmico, ma l’informazione e le correlazioni quantistiche tra i mattoni fondamentali dell’universo. Lo spazio e il tempo che percepiamo sarebbero quindi una sorta di illusione collettiva, il risultato macroscopico di relazioni invisibili.
La scala di Planck: dove la geometria si frantuma
Per capire dove comincia questa rivoluzione concettuale, occorre scendere in un regno minuscolo, ben oltre ciò che i nostri sensi o gli strumenti tradizionali possono afferrare. La cosiddetta lunghezza di Planck, circa \(10^{−35}\) metri, rappresenta la frontiera in cui le nostre leggi smettono di funzionare. Si arriva a questo numero combinando tre costanti fondamentali: la velocità della luce, che stabilisce il limite ultimo della propagazione dell’informazione; la costante di Planck, che regola la quantizzazione dell’energia; e la costante gravitazionale, che misura l’intensità della gravità.
Quantizzazione dell’energia
L’idea intuitiva
Nella fisica classica, cioè quella che descrive il mondo dei pianeti, delle onde del mare e delle palle che rimbalzano, l’energia può assumere qualsiasi valore. Se lanci una palla più forte o più piano, la sua energia può crescere o diminuire in modo continuo, come una rampa liscia senza gradini.
Con la meccanica quantistica, invece, si scopre che a livello microscopico l’energia non è continua, ma è fatta di “pacchetti discreti”, cioè valori separati tra loro. È come se la scala non fosse liscia, ma composta da gradini: puoi stare su un gradino o sull’altro, ma non in mezzo.
L’origine della scoperta
Questa idea nacque all’inizio del Novecento, quando Max Planck cercava di spiegare la radiazione emessa dai corpi caldi (per esempio il colore della luce di una stufa incandescente). I calcoli classici non funzionavano: prevedevano un’esplosione infinita di energia alle alte frequenze, il cosiddetto “catastrofe ultravioletta”.
Planck propose allora un’ipotesi rivoluzionaria: l’energia della radiazione non può variare in modo continuo, ma viene emessa e assorbita in multipli discreti di una quantità fondamentale, chiamata quanto. Questa quantità dipende dalla frequenza della radiazione ed è proporzionale alla costante di Planck, h.
In formula: \(E = n h \nu \qquad \text{con } n = 0,1,2,\ldots\)
dove EEE è l’energia, ν è la frequenza e h è la costante di Planck.
Un esempio concreto: l’atomo di idrogeno
Prendiamo l’atomo più semplice, quello di idrogeno. Secondo la meccanica classica, l’elettrone dovrebbe poter orbitare attorno al nucleo a qualsiasi distanza, con qualsiasi energia. Ma gli esperimenti mostrano che gli elettroni possono occupare solo orbite precise, ciascuna con una certa energia ben definita.
Se un elettrone vuole cambiare orbita, non può farlo “pian piano”: deve saltare da un livello a un altro, assorbendo o emettendo un quanto di energia sotto forma di fotone (cioè un pacchetto di luce). È proprio questa quantizzazione che spiega le righe spettrali osservate nella luce delle stelle o nelle lampade al neon: ogni riga corrisponde a un salto quantico ben preciso.
Perché è così importante?
La quantizzazione dell’energia è alla base di tutta la fisica moderna. Senza di essa:
- non si capirebbe la stabilità degli atomi,
- non esisterebbero i laser, i semiconduttori, i LED,
- la chimica e la biologia molecolare sarebbero inspiegabili.
In sostanza, il fatto che l’energia sia quantizzata è ciò che permette alla materia di avere una struttura stabile e al nostro universo di essere così come lo conosciamo.
Quando proviamo a “guardare” sotto quella soglia, i concetti di spazio e tempo si disfano. Per localizzare un oggetto molto precisamente serve una grande quantità di energia; ma se ne concentriamo troppa in una regione piccolissima, si forma un buco nero che nasconde tutto dietro il suo orizzonte. In pratica, la natura ci dice che non possiamo spingerci oltre. Lo spaziotempo, sotto quella scala, non è più liscio né continuo: si immagina piuttosto come una schiuma quantistica, un mare ribollente di fluttuazioni, dove i concetti di distanza e durata non hanno più senso.
Due teorie che non si parlano: relatività e meccanica quantistica
A rendere la questione ancora più intricata c’è il fatto che la fisica moderna poggia su due pilastri, splendidi ma incompatibili. La meccanica quantistica descrive il mondo microscopico, fatto di probabilità, superposizioni e discreti “quanti” di energia. La relatività generale, invece, descrive il cosmo su larga scala, dove la gravità non è una forza misteriosa ma la curvatura dello spaziotempo stesso.
Il problema nasce quando proviamo a combinarle. Nella quantistica il tempo è un parametro esterno, un orologio universale che scandisce l’evoluzione degli stati. Nella relatività, invece, il tempo fa parte della geometria, può rallentare o accelerare, non è assoluto. Le due concezioni non s’incastrano.
In più, la relatività tratta lo spaziotempo come un continuum infinitamente divisibile, mentre la quantistica ci suggerisce che la realtà sia granulosa, fatta di unità minime. Quando cerchiamo di quantizzare la gravità, i calcoli producono infiniti che non si riescono a eliminare. È come cercare di scrivere una partitura in due linguaggi musicali diversi, che seguono scale inconciliabili.
I punti ciechi della relatività: Big Bang e buchi neri
La relatività generale funziona magnificamente per descrivere galassie, onde gravitazionali, satelliti. Ma in alcuni scenari estremi, ci conduce a vicoli ciechi. Il Big Bang ne è l’esempio più radicale: se torniamo indietro nel tempo, le equazioni ci portano a un punto di densità infinita, una singolarità in cui lo spazio e il tempo stessi si annullano. Ma cosa significa “prima del tempo”? È un concetto che la teoria non riesce a gestire.
Stesso discorso per i buchi neri. La relatività prevede che, al centro, tutto collassi in una singolarità di densità infinita. Ancora una volta, infinita. Un segnale che la teoria non descrive più la realtà, ma indica il proprio limite. Sono questi paradossi che hanno spinto i fisici a cercare una nuova teoria, capace di unire il piccolo e il grande.
L’entropia dei buchi neri: informazione scolpita sulla superficie
Negli anni Settanta, Jacob Bekenstein ebbe un’intuizione brillante: se un oggetto che contiene informazione cade in un buco nero, quell’informazione non può svanire senza violare la seconda legge della termodinamica. Ne derivò che i buchi neri devono avere entropia, e questa entropia deve essere proporzionale all’area del loro orizzonte degli eventi.
Poco dopo, Stephen Hawking dimostrò che i buchi neri non sono eternamente silenziosi: emettono radiazione, hanno una temperatura e possono evaporare. La formula che lega massa, superficie e temperatura mostra che l’entropia è collegata alla superficie, non al volume. È come se tutta l’informazione di ciò che è caduto dentro si conservasse sul bordo, come una pellicola sottile che registra ogni evento.
Questa scoperta non è un dettaglio tecnico, ma un indizio enorme: forse l’intero universo funziona così. Forse la realtà tridimensionale che percepiamo è proiettata da informazioni bidimensionali. È la nascita del cosiddetto principio olografico.
Il principio olografico e la corrispondenza AdS/CFT
Il principio olografico crea una congettura più ampia: forse tutta la realtà funziona così. In altre parole, una regione tridimensionale dello spazio non sarebbe fondamentale, ma potrebbe essere descritta completamente dalle informazioni presenti sul suo “confine” bidimensionale. L’universo, dunque, potrebbe somigliare a un gigantesco ologramma: ciò che percepiamo come volume e profondità emergerebbe a partire da un “codice” impresso sulla superficie.
Questa intuizione trovò una formulazione matematica molto precisa nel 1997 grazie a Juan Maldacena, che propose la cosiddetta corrispondenza AdS/CFT. In essa, due teorie apparentemente diversissime risultano equivalenti:
- da un lato, una teoria della gravità quantistica che vive in uno spazio a curvatura negativa (chiamato spazio anti-de Sitter, o AdS);
- dall’altro, una teoria quantistica dei campi senza gravità, che esiste sul bordo di quello stesso spazio, quindi in una dimensione in meno.
La bellezza di questa dualità è che fenomeni geometrici e gravitazionali in “bulk”, cioè nell’interno dello spazio AdS, corrispondono a fenomeni puramente quantistici descritti dalla teoria di confine. Ciò potrebbe significare che concetti come spazio, tempo e gravità emergono da un linguaggio più profondo, quello delle interazioni quantistiche.
In sintesi: il principio olografico ci dice che l’universo tridimensionale che vediamo potrebbe essere la proiezione di informazioni fondamentali codificate su una superficie più semplice. E la corrispondenza AdS/CFT è il primo esempio rigoroso di come questa idea possa funzionare nei dettagli matematici.
Lo spaziotempo come emergenza dall’entanglement
Immagina di pensare allo spazio non come a un palcoscenico preesistente, ma come a un tessuto fatto di fili invisibili. Questi fili sono le correlazioni quantistiche, ciò che in fisica chiamiamo entanglement. Due particelle entangled, anche se lontanissime, condividono uno stato comune: sapere qualcosa dell’una ci dice immediatamente qualcosa dell’altra.
Il fisico Mark Van Raamsdonk ha proposto un esperimento mentale che rende questa idea molto chiara. Partiamo da una situazione particolare della corrispondenza AdS/CFT, in cui lo spazio curvo di tipo AdS è collegato a una teoria quantistica definita sul suo bordo. In questa teoria, possiamo controllare il grado di entanglement tra diverse regioni del sistema quantistico.
Ora, Van Raamsdonk immagina di ridurre gradualmente l’entanglement tra le parti del sistema. Cosa accade? All’inizio lo spazio appare come un unico tessuto continuo. Ma man mano che diminuiamo l’entanglement, il tessuto inizia a strapparsi: le regioni che prima erano collegate si separano sempre di più, finché, se l’entanglement svanisce del tutto, lo spazio stesso si disintegra in frammenti scollegati, senza nessuna continuità geometrica.
L’esperimento mentale non è qualcosa che si possa realizzare in laboratorio, ma ha un enorme valore concettuale: mostra che la continuità dello spazio non è fondamentale, bensì dipende dalla quantità di entanglement. In altre parole, lo spazio non è un contenitore dato una volta per tutte, ma il prodotto emergente di connessioni quantistiche invisibili. È la rete di correlazioni che “tiene insieme” la realtà e dà origine alla sensazione di un ambiente spaziale continuo.
Un paragone semplice è quello di un puzzle: quando i pezzi sono incastrati tra loro, vediamo un’unica immagine continua. Ma se spezziamo le connessioni, il quadro si frantuma in tessere isolate. Allo stesso modo, senza entanglement, lo spazio collasserebbe in frammenti disconnessi.
La congettura ER=EPR va nella stessa direzione: suggerisce che ogni coppia di particelle entangled possa essere vista come unita da un minuscolo wormhole. Non sono passaggi attraversabili, ma rappresentano la traduzione geometrica dell’entanglement. Lo spazio si costruisce letteralmente con fili di informazione.
ER=EPR
Negli ultimi anni, due fisici, Juan Maldacena e Leonard Susskind, hanno proposto una congettura affascinante che unisce due idee apparentemente lontane: i wormhole della relatività generale e l’entanglement quantistico. La chiamarono ER=EPR.
Il nome è un po’ tecnico, ma si capisce facilmente:
- ER sta per Einstein-Rosen, dal famoso “ponte” che Einstein e Rosen ipotizzarono nel 1935, quello che oggi chiamiamo wormhole, una galleria nello spazio-tempo che collega due punti lontani.
- EPR si riferisce invece al celebre paradosso di Einstein, Podolsky e Rosen, sempre del 1935, che introdusse il concetto di entanglement quantistico.
La congettura dice una cosa sorprendente: ogni coppia di particelle entangled può essere vista come collegata da un minuscolo wormhole. Non si tratta di tunnel attraversabili come nella fantascienza: nessuno può usarli per viaggiare da una particella all’altra. Ma questa immagine fornisce una traduzione geometrica dell’entanglement: laddove due particelle sono correlate in maniera profonda, la geometria dello spaziotempo può essere pensata come “cucita” da un piccolo ponte invisibile.
L’esperimento mentale
Immagina di avere due particelle entangled. Le separi e le porti ai lati opposti della galassia. Secondo la meccanica quantistica, rimangono comunque collegate: se misuri una, istantaneamente conosci lo stato dell’altra. Einstein chiamava questo fenomeno “azione spettrale a distanza”, perché gli sembrava quasi magico.
Ora, prova a descrivere la stessa situazione in linguaggio geometrico, come farebbe un relativista. Invece di pensare a due particelle lontanissime, immaginale come unite da un sottilissimo ponte nello spaziotempo. Questo ponte non è percorribile da materia o segnali — quindi non viola la relatività — ma spiega perché le due particelle si comportano come se fossero ancora “vicine”.
In questa visione, lo spazio stesso si costruisce non come una griglia data a priori, ma come una rete di fili informazionali: ogni legame di entanglement aggiunge un filo, ogni filo cuce un pezzo di geometria. Aumentando i collegamenti, lo spazio diventa più robusto e continuo; diminuendoli, tende a strapparsi e frammentarsi.
Perché è così importante
L’idea ER=EPR non è una teoria definitiva, ma una congettura suggestiva che punta nella stessa direzione del principio olografico e dell’esperimento mentale di Van Raamsdonk: lo spaziotempo potrebbe essere il risultato emergente di una rete di correlazioni quantistiche. In questa immagine, il cosmo assomiglia a un tessuto fatto non di fili materiali, ma di informazione pura.
Modelli più recenti, come le reti tensoriali, mostrano come un intricato intreccio di qubit entangled possa produrre una geometria che ricorda lo spaziotempo continuo. È come se lo spazio emergesse dal tessuto delle relazioni, proprio come una tela appare dal modo in cui i fili sono intrecciati.
Reti tensoriali
Un tensore, in termini molto semplici, è come una tabella che raccoglie numeri e relazioni tra più variabili contemporaneamente. Ora, se colleghiamo tanti tensori in una rete, come se fossero nodi uniti da fili, otteniamo una struttura complessa capace di codificare stati quantistici molto ricchi. In queste reti, i fili rappresentano proprio l’entanglement tra i qubit, cioè le unità di informazione quantistica.
Quello che i ricercatori hanno scoperto è sorprendente: se si disegna questa rete con una certa geometria, la struttura che emerge ricorda in modo naturale lo spaziotempo continuo. Le correlazioni quantistiche, intrecciate tra loro, danno origine a una forma che assomiglia a una superficie curva, quasi una piccola “miniatura” di spazio.
L’esperimento mentale
Immagina di avere un grande tessuto di fili intrecciati. Se osservi i fili da vicino, non vedi altro che nodi e connessioni. Ma se ti allontani, la trama diventa una superficie uniforme, come un telo di stoffa. La stoffa in sé non esiste indipendentemente dai fili: è solo l’effetto collettivo del loro intreccio.
Allo stesso modo, nelle reti tensoriali, i qubit entangled sono come i fili. Se ne colleghi pochi, la struttura resta grezza e frammentata. Ma man mano che aumenti il numero di correlazioni, il tessuto si fa più regolare, fino ad assumere le proprietà di uno spazio liscio e continuo. La geometria non era lì in partenza: è emersa dal modo in cui gli elementi di base (i qubit) sono stati intrecciati.
Il significato profondo
Le reti tensoriali sono modelli semplificati, certo, ma mostrano in modo concreto un principio fondamentale: lo spazio potrebbe non essere un ingrediente di base, ma il risultato del tessuto di relazioni quantistiche. È come se l’universo fosse una tela che appare ai nostri occhi solo perché, a livello microscopico, qubit entangled si intrecciano secondo schemi precisi.
Ricerche recenti e prospettive
Negli ultimi anni, vari studi hanno provato a formalizzare queste intuizioni. Alcuni propongono che l’universo sia il risultato di un enorme “circuito quantistico”, in cui le connessioni tra qubit danno origine allo spaziotempo che osserviamo. Altri esplorano i limiti: se c’è troppo entanglement, lo spazio non emerge affatto. Ci vuole la giusta dose e organizzazione delle correlazioni.
Riviste scientifiche come Physical Review Letters e Journal of High Energy Physics hanno pubblicato articoli che cercano di costruire modelli concreti in cui la geometria nasca da matrici quantistiche o da stati entangled su larga scala. Si tratta ancora di tentativi, ma tutti puntano a una stessa direzione: lo spaziotempo non è la base, ma l’effetto.
Cosa significa per noi: la realtà come relazione
Se queste idee si rivelassero corrette, la nostra immagine del mondo cambierebbe radicalmente. Non ci sarebbero più particelle che “abitano” lo spazio, ma informazioni e relazioni che producono lo spazio stesso. Non ci sarebbe un tempo universale che scorre, ma un senso di cambiamento emergente dalle trasformazioni dell’entanglement.
In filosofia, da sempre ci si chiede se lo spazio sia un’entità reale o solo una relazione tra oggetti. Le nuove teorie sembrano rispondere: è relazione. È l’intreccio invisibile che dà forma alla scena. Noi stessi, come esseri coscienti, siamo parte di questa rete: un nodo di informazioni e connessioni.
Conclusione – l’illusione collettiva dello spazio e del tempo
Lo spaziotempo, allora, non sarebbe il grande palco eterno che immaginavamo, ma un’illusione emergente. È il risultato della danza dell’informazione quantistica, dei fili sottili che legano i qubit in uno stato di entanglement. Ciò che percepiamo come distanza, durata, geometria, è solo un linguaggio collettivo che la natura adotta su larga scala.
Il paradosso è che questa illusione funziona alla perfezione: permette di costruire ponti, satelliti, interi universi di equazioni. Ma sotto di essa, forse, non c’è né spazio né tempo. C’è solo connessione.
Riferimenti bibliografici
Paper fondazionali
- Bekenstein, J.D. (1973). Black Holes and Entropy. Physical Review D, 7, 2333–2346. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.7.2333
- Hawking, S.W. (1974). Black hole explosions? Nature, 248, 30–31. https://doi.org/10.1038/248030a0
- Hawking, S.W. (1975). Particle Creation by Black Holes. Communications in Mathematical Physics, 43, 199–220. https://doi.org/10.1007/BF02345020
- ’t Hooft, G. (1993). Dimensional Reduction in Quantum Gravity. arXiv:gr-qc/9310026
- Susskind, L. (1995). The World as a Hologram. Journal of Mathematical Physics, 36, 6377–6396. arXiv:hep-th/9409089
- Maldacena, J. (1997). The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity. arXiv:hep-th/9711200
- Ryu, S., & Takayanagi, T. (2006). Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT. Physical Review Letters, 96, 181602. arXiv:hep-th/0603001
- Van Raamsdonk, M. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. General Relativity and Gravitation, 42, 2323–2329. arXiv:1005.3035
- Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. Fortschritte der Physik, 61, 781–811. arXiv:1306.0533
Review articles
- Bousso, R. (2002). The Holographic Principle. Reviews of Modern Physics, 74, 825–874. arXiv:hep-th/0203101
- Hubeny, V. (2015). The AdS/CFT Correspondence. arXiv:1501.00007
- Van Raamsdonk, M. (2016). Lectures on Gravity and Entanglement. arXiv:1609.00026
- Ashtekar, A., & Bianchi, E. (2021). A Short Review of Loop Quantum Gravity. arXiv:2104.04394
Sviluppi recenti (2020–2024)
- Almheiri, N., Mahajan, R., Maldacena, J., & Zhao, Y. (2020). The Page curve of Hawking radiation from semiclassical geometry. Journal of High Energy Physics, 03, 149. arXiv:1908.10996
- Almheiri, N., Hartman, T., Maldacena, J., Shaghoulian, E., & Tajdini, A. (2020). Replica Wormholes and the Entropy of Hawking Radiation. Journal of High Energy Physics, 05, 013. arXiv:1911.12333
- Van Raamsdonk, M. (2020). Spacetime from bits. Science, 370(6513), 198–202. https://doi.org/10.1126/science.aay9560
- Cheung, C., Hillman, A., & Remmen, G.N. (2024). Bootstrap Principle for the Spectrum and Scattering of Strings. Physical Review Letters, 133, 251601. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.251601
- Oppenheim, J. (2023). A Postquantum Theory of Classical Gravity? Physical Review X, 13, 041040. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.041040
Risorse enciclopediche
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. Quantum Gravity. https://plato.stanford.edu/entries/quantum-gravity/
- Harlow, D. (2018). TASI Lectures on the Emergence of the Bulk in AdS/CFT. arXiv:1802.01040
- Maldacena, J. (2024). The AdS/CFT Correspondence. In: Handbook of Quantum Gravity. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3079-9_65-1
Articoli divulgativi di riferimento
- Maldacena, J. (2013). Entanglement and the Geometry of Spacetime. Institute for Advanced Study. https://www.ias.edu/ideas/2013/maldacena-entanglement
- Juan Maldacena: Pondering Quantum Gravity by the Pond. Quanta Magazine, 2017. https://www.quantamagazine.org/juan-maldacena-pondering-quantum-gravity-by-the-pond-20170623/
- Wormhole Entanglement and the Firewall Paradox. Quanta Magazine, 2015. https://www.quantamagazine.org/wormhole-entanglement-and-the-firewall-paradox-20150424/