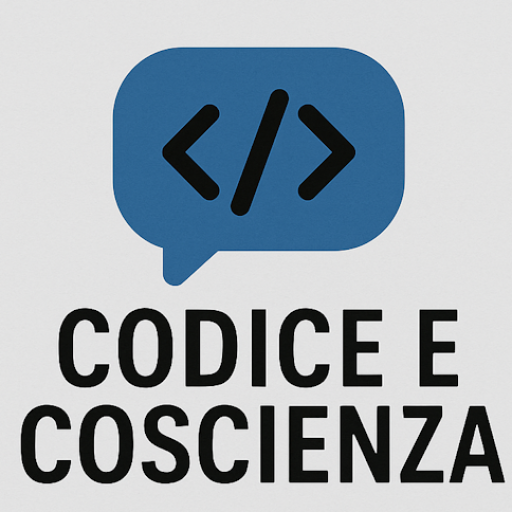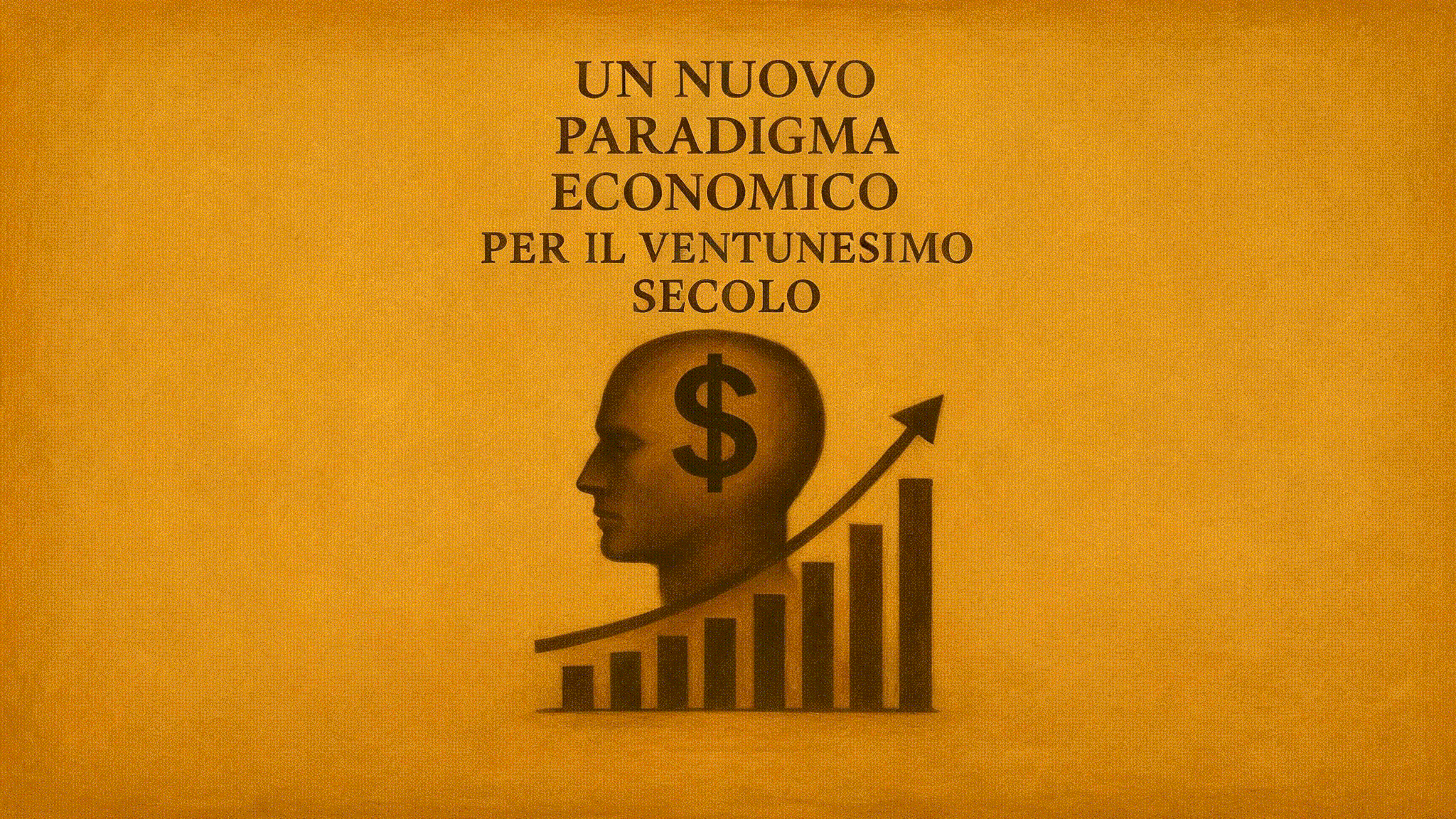Dopo anni di osservazione dei modelli economici contemporanei, sono giunto alla conclusione che tanto il capitalismo puro quanto il socialismo centralizzato rappresentano configurazioni subottimali per l’organizzazione economica del ventunesimo secolo. Riconosco i ricorrenti schemi di fallimento in entrambi gli approcci: il capitalismo produce instabilità strutturale e un’estrema concentrazione della ricchezza, mentre il socialismo soffre di problemi informativi e disallineamento degli incentivi, che rendono impossibile un’allocazione efficiente delle risorse.
La mia proposta per un modello economico ibrido nasce dall’osservazione che i sistemi più resilienti in natura e nell’ingegneria sono quelli che combinano molteplici meccanismi di controllo e feedback, adattandosi dinamicamente alle condizioni ambientali piuttosto che ottimizzare per un singolo parametro. Questo articolo presenta un modello sistemico che integra meccanismi di mercato, gestione partecipativa, e principi di sostenibilità ecologica in una sintesi funzionale e operativa.
I fallimenti sistemici dei modelli economici tradizionali
L’osservazione rivela che il capitalismo contemporaneo presenta quattro vulnerabilità strutturali che ne compromettono la stabilità a lungo termine. Prima fra tutte, la concentrazione di ricchezza ha raggiunto livelli storicamente critici: nei paesi OCSE, il 10% più ricco guadagna oggi 9,5 volte il reddito del 10% più povero, rispetto al rapporto 7:1 degli anni ’80. Come dimostra una ricerca di Thomas Piketty, quando il tasso di rendimento del capitale supera il tasso di crescita economica, si innesca un processo di concentrazione patrimoniale autosostenuta che mina le basi democratiche del sistema.
Approfondimento…
L’idea si basa su una dinamica matematica ed economica precisa:
Tasso di rendimento del capitale (r): è quanto rende, in media, la proprietà del capitale (azioni, immobili, obbligazioni, imprese, terre, ecc.). Se ad esempio possiedo ricchezza investita che frutta il 5% annuo, il mio patrimonio cresce a quel ritmo.
Tasso di crescita economica (g): indica quanto cresce complessivamente l’economia (produttività, salari medi, PIL).Se r > g, cioè se chi ha capitale ottiene rendimenti più alti di quanto cresca l’economia reale e i redditi da lavoro, succede questo:
Accumulo più rapido dei capitali: i patrimoni già esistenti crescono più velocemente dei redditi da lavoro. Chi parte con ricchezza viene avvantaggiato molto di più rispetto a chi vive solo del proprio salario.
Divario crescente: la disparità tra ricchi e resto della popolazione si amplia nel tempo, perché i redditi da lavoro non riescono a stare al passo con i redditi da capitale.
Concentrazione patrimoniale: pochi individui o famiglie finiscono per possedere una quota crescente della ricchezza complessiva della società.
Effetti politici e sociali: quando la ricchezza si concentra troppo, chi la detiene ha anche maggiore influenza su media, istituzioni, politica e regole del gioco. Col tempo, questo può corrodere le basi democratiche, perché il potere effettivo non è più distribuito tra i cittadini ma concentrato in una ristretta elite.In sintesi, se i capitali producono redditi più velocemente di quanto cresce l’economia, la disuguaglianza diventa strutturale, alimentandosi da sola e rischiando di destabilizzare sia l’equilibrio sociale che quello democratico.
Il secondo punto debole riguarda l’esternalizzazione sistematica dei costi ambientali. Le aziende riversano sulla collettività spese ingenti, stimate in milioni di dollari, per la gestione dell’inquinamento, mentre i profitti rimangono privati. Questo meccanismo contribuisce all’aumento delle concentrazioni di CO2, passate dalle 280 parti per milione (ppm) dell’era pre-industriale a oltre 420 ppm attuali. Si tratta di un classico caso in cui l’ottimizzazione a livello locale produce un risultato subottimale a livello globale.
Il terzo problema è la miopia temporale generata dalla pressione dei mercati finanziari. I bilanci trimestrali spingono le imprese a massimizzare i profitti immediati, sacrificando gli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo del capitale umano. La crescente finanziarizzazione dell’economia ha spostato l’attenzione dalla produzione di valore concreto all’elaborazione di operazioni finanziarie fini a sé stesse.
Parallelamente, i sistemi socialisti centralizzati falliscono per ragioni informatiche fondamentali. Come dimostrarono Mises e Hayek, l’assenza di segnali di prezzo rende impossibile il calcolo economico razionale in economie complesse con milioni di prodotti e infinite possibilità produttive. I pianificatori centrali non possono processare questa complessità informativa senza meccanismi di mercato che aggreghino la conoscenza dispersa.
Approfondimento…
Il paragrafo si riferisce al problema del calcolo economico nei sistemi socialisti centralizzati, discusso soprattutto da Ludwig von Mises e Friedrich Hayek nel XX secolo.
La questione di fondo
In un’economia complessa esistono milioni di beni e servizi, diverse tecnologie possibili e risorse limitate (tempo, lavoro, materie prime). La sfida è decidere cosa produrre, quanto produrne e come allocare le risorse in modo efficiente.
Il ruolo dei prezzi nei mercati
In un sistema di mercato, i prezzi funzionano come segnali che condensano informazioni disperse:
- Quando la domanda aumenta, i prezzi salgono → le imprese capiscono che conviene produrre di più.
- Quando un bene scarseggia, il prezzo cresce → segnale che bisogna usarlo con parsimonia o trovare alternative.
- Quando una tecnologia diventa più efficiente, i costi scendono → incentivo a investirci.
In pratica i prezzi permettono a milioni di decisioni locali di coordinarsi spontaneamente senza bisogno di un controllo centrale.
Il problema del socialismo centralizzato
In un sistema senza mercato (e dunque senza prezzi emersi dalla libera interazione), i pianificatori centrali devono decidere tutto dall’alto: quanti chiodi produrre, dove allocare il ferro, quanta energia destinare all’acciaio o ai frigoriferi, ecc.
- Ma la quantità di informazioni da elaborare è immensa e mutevole.
- Non esistono segnali di prezzo “veri” che riflettano preferenze e scarsità.
- Anche con computer o algoritmi avanzati, il problema resta difficile perché le informazioni sono distribuite tra milioni di agenti e mutano di continuo.
La conclusione di Mises e Hayek
Senza prezzi di mercato, non si riesce a valutare razionalmente i costi e i benefici delle scelte economiche. Di conseguenza, le economie centralizzate tendono a:
- generare sprechi e inefficienze,
- sovraprodurre alcuni beni e sottoprodurne altri,
- non incentivare innovazione e adattamento.
In sintesi, il punto è che un pianificatore centrale non può processare tutta la complessità informativa necessaria a gestire un’economia moderna. I mercati, pur imperfetti, svolgono questa funzione in modo più efficiente grazie al sistema dei prezzi che aggrega informazioni disperse nella società.
Il problema degli incentivi completa il quadro: nei sistemi socialisti vengono a mancare i legami tra risultati e ricompense, spezzando la connessione tra l’impegno individuale e gli esiti collettivi. L’esperienza sovietica ha confermato empiricamente queste critiche teoriche, mostrando una stagnazione della produttività dagli anni Settanta fino al collasso del sistema nel 1991.
Principi fondamentali per il benessere umano in sistemi economici avanzati
Un sistema economico ottimale deve operare all’interno di quello che Kate Raworth definisce lo “spazio sicuro e giusto”: l’area compresa tra la base sociale (assicurare che nessuno resti privo dei bisogni fondamentali) e il tetto ecologico (i limiti planetari, considerare che il pianeta ha risorse limitate). Questo modello, chiamato a “ciambella”, costituisce uno strumento operativo per bilanciare sostenibilità ambientale e giustizia sociale.
Il vero benessere umano va oltre l’accumulo materiale: include qualità della vita, salute, relazioni significative, fiducia reciproca e partecipazione democratica. Come afferma Tim Jackson, la prosperità senza crescita non è solo possibile, ma necessaria in un mondo con risorse limitate. Ciò richiede distinguere fra crescita quantitativa (aumento delle dimensioni economiche) e sviluppo qualitativo (avanzamento tecnologico, miglioramento progettuale ed evoluzione etica).
L’economia della post-crescita, proposta da Herman Daly, sottolinea che in un “mondo pieno” la crescita infinita diventa controproducente e deve lasciare spazio a un orientamento verso il miglioramento del benessere umano entro i limiti ecologici. In pratica, significa progettare sistemi che puntino al flusso sostenibile di risorse piuttosto che alla mera massimizzazione del prodotto interno lordo.
Mondo Pieno…
è un concetto chiave nell’economia ecologica, reso popolare da Herman Daly. Significa che la Terra non è più un “mondo vuoto” con risorse abbondanti e una capacità illimitata di assorbire i nostri rifiuti.
In un “mondo vuoto” (come era percepito in passato, o come lo era effettivamente prima della rivoluzione industriale e della crescita demografica esponenziale):
- Le risorse naturali (terra, acqua, minerali, foreste) erano considerate virtualmente infinite rispetto alla scala dell’attività umana.
- La capacità dell’ambiente di assorbire inquinamento e rifiuti era vista come illimitata.
- L’economia era piccola rispetto all’ecosfera.
In un “mondo pieno“:
- L’economia umana è diventata così grande che le sue attività hanno un impatto significativo e spesso negativo sull’ecosistema globale.
- Le risorse naturali non sono più abbondanti; molte sono scarse o si stanno esaurendo.
- La capacità degli ecosistemi di assorbire inquinamento (come la CO2 nell’atmosfera o i rifiuti nei mari) è stata superata, portando a crisi ambientali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l’acidificazione degli oceani.
- Siamo arrivati ai “limiti planetari”, ovvero soglie oltre le quali i sistemi naturali della Terra potrebbero subire cambiamenti irreversibili e dannosi per la vita umana.
Quindi, quando si parla di “mondo pieno”, si intende che la crescita economica e demografica ha saturato la capacità del pianeta di fornire risorse e assorbire impatti, rendendo insostenibile il modello di sviluppo basato sulla crescita continua e illimitata. In questo contesto, l’obiettivo non è più solo la crescita del PIL, ma la gestione sostenibile delle risorse e il miglioramento del benessere umano entro i limiti ecologici del pianeta.
Il modello dell’economia a ciambella fornisce anche metriche concrete: garantire l’accesso universale a cibo, casa, sanità, istruzione, reddito, pace e giustizia, energia, acqua, comunicazioni e partecipazione politica, restando al tempo stesso entro i confini planetari, che comprendono cambiamento climatico, acidificazione degli oceani, inquinamento chimico, eccesso di azoto e fosforo, prelievo di acqua dolce, cambiamento d’uso del suolo, perdita di biodiversità, inquinamento atmosferico e riduzione dell’ozono stratosferico.
Natura umana e cooperazione condizionale come fondamenti progettuali
La ricerca in economia comportamentale mostra che gli esseri umani sono cooperatori condizionali più che massimizzatori di utilità puramente egoistici o altruisti incondizionati. Ernst Fehr e collaboratori hanno dimostrato che circa il 30-50% delle persone manifesta una reciprocità forte: la tendenza a cooperare se altri cooperano e a punire chi viola le regole, anche a costo personale.
Questa struttura motivazionale genera dinamiche complesse nelle popolazioni eterogenee. I cooperatori condizionali (circa il 50% dei partecipanti negli esperimenti) modulano il loro comportamento in base al livello atteso di cooperazione altrui, mentre i parassiti sociali (free riders, circa il 30%) si sottraggono sistematicamente agli obblighi, indipendentemente dal comportamento degli altri. La presenza di soggetti con reciprocità forte, disposti a punire i parassiti sociali, può stabilizzare la cooperazione su livelli elevati.
Gli esperimenti con il gioco dell’ultimatum mostrano in modo sistematico che le persone rifiutano offerte ingiuste anche a costo personale, rivelando una preferenza profonda per l’equità. I modelli di avversione all’iniquità dimostrano che gli individui traggono soddisfazione non solo dal proprio guadagno assoluto, ma anche dalla giustizia percepita degli esiti.
Gioco dell’ultimatum…
Immagina questa situazione:
Ci sono due giocatori e una somma di denaro, diciamo 100 euro.
Il Proponente: Il primo giocatore (il proponente) deve decidere come dividere i 100 euro. Può fare qualsiasi offerta, ad esempio:
- 50 euro a me e 50 a te
- 90 euro a me e 10 a te
- 10 euro a me e 90 a te
- …o qualsiasi altra divisione.
Il Rispondente: Il secondo giocatore (il rispondente) ha solo due opzioni:
- Accettare l’offerta: Se accetta, il denaro viene diviso esattamente come proposto dal primo giocatore.
- Rifiutare l’offerta: Se rifiuta, nessuno dei due giocatori riceve nulla. I 100 euro tornano indietro e nessuno prende niente.
Cosa ci si aspetterebbe da un “massimizzatore di utilità” puramente razionale ed egoista?
- Il Rispondente razionale: Accetterebbe qualsiasi offerta superiore a zero. Anche 1 euro è meglio di niente, quindi dovrebbe accettare 99 euro al proponente e 1 euro a sé stesso.
- Il Proponente razionale: Sapendo questo, offrirebbe la minima somma possibile (ad esempio 1 euro) al rispondente, tenendo per sé 99 euro, perché sa che il rispondente “razionale” accetterà.
Cosa succede nella realtà (negli esperimenti)?
Gli esperimenti con il gioco dell’ultimatum mostrano sistematicamente che le persone non si comportano in questo modo puramente egoistico:
- Offerte ingiuste vengono rifiutate: Se il proponente offre una somma troppo bassa (ad esempio, 80 euro a sé e 20 euro al rispondente, o peggio), il rispondente spesso rifiuta l’offerta, anche se questo significa non prendere nulla.
- Preferenza per l’equità: I rispondenti sono disposti a sacrificare un guadagno personale pur di punire un’offerta che percepiscono come ingiusta. Questo dimostra che le persone hanno una forte preferenza per l’equità e la giustizia, e non sono solo motivate dal proprio guadagno materiale.
- Offerte più eque: Di conseguenza, i proponenti, sapendo che offerte troppo sbilanciate verranno rifiutate, tendono a fare offerte più eque (spesso intorno al 40-50% della somma totale) per assicurarsi che vengano accettate.
In sintesi, il gioco dell’ultimatum è un esperimento che rivela come le nostre decisioni economiche non siano guidate solo dalla logica del massimo guadagno personale, ma anche da considerazioni di equità, giustizia e reciprocità.
Queste scoperte hanno implicazioni decisive per la progettazione delle istituzioni. I sistemi economici devono collaborare con la natura umana invece di contrastarla, valorizzando le capacità innate di reciprocità e cooperazione, mentre gestiscono i comportamenti opportunistici attraverso incentivi e regole adeguate.
Il capitale sociale e la fiducia reciproca riducono i costi di transazione e rendono possibile la cooperazione senza bisogno di controlli capillari. La fiducia generalizzata nasce dalla partecipazione ad associazioni volontarie e gruppi civici, creando un circolo virtuoso che sostiene crescita economica, democrazia e benessere sociale.
Meccanismi ibridi di allocazione delle risorse
Il cuore del modello economico ibrido risiede nella combinazione intelligente di meccanismi di allocazione che sfruttano i vantaggi del mercato dove esso è efficiente, ricorrendo invece alla gestione democratica e alla pianificazione partecipativa laddove il mercato fallisce.
Per i beni privati, caratterizzati da rivalità nell’uso ed escludibilità, i meccanismi di mercato restano superiori nel coordinare informazioni diffuse e nel fornire incentivi all’innovazione. Tuttavia, tali mercati devono operare entro quadri regolatori che internalizzino i costi ambientali e sociali e impediscano eccessive concentrazioni di potere monopolistico.
Per i beni pubblici e i beni comuni, la ricerca di Elinor Ostrom ha dimostrato che la gestione comunitaria può risultare più efficace sia del mercato sia della regolamentazione statale. I suoi principi includono: confini chiaramente definiti, coerenza tra regole e condizioni locali, processi di scelta collettiva, monitoraggio, sanzioni graduate, strumenti di risoluzione dei conflitti, riconoscimento del diritto all’auto-organizzazione e sistemi di governo multilivello.
Gestione comunitaria…
Immagina un piccolo villaggio di montagna che dipende da un pascolo comune per il bestiame di tutte le famiglie. Questo pascolo è un “bene comune”: non è di proprietà di nessuno in particolare, ma è essenziale per la sopravvivenza di tutti.
Se non ci fossero regole, cosa potrebbe succedere?
- Ogni pastore potrebbe essere tentato di portare più bestiame possibile per massimizzare il proprio guadagno.
- Il pascolo verrebbe sfruttato eccessivamente, l’erba non farebbe in tempo a ricrescere, e alla fine il pascolo si degraderebbe, danneggiando tutti. Questo è ciò che a volte viene chiamato la “tragedia dei beni comuni”.
Qui entra in gioco la gestione comunitaria, basata sui principi studiati da Elinor Ostrom:
- Le regole nascono dalla comunità: Invece di aspettare che lo Stato imponga una legge o che un’azienda privata compri il pascolo, i pastori del villaggio si riuniscono e decidono insieme le regole.
- Confini chiari: Stabiliscono esattamente quali sono i confini del pascolo comune e chi ha il diritto di usarlo (solo i residenti del villaggio, ad esempio).
- Regole d’uso specifiche: Decidono quante bestie ogni famiglia può portare al pascolo, o in quali periodi dell’anno si può pascolare per permettere all’erba di rigenerarsi. Queste regole sono adatte alle condizioni specifiche di quel pascolo e di quel villaggio.
- Monitoraggio: I pastori stessi, o un comitato eletto tra loro, si occupano di controllare che tutti rispettino le regole. Non c’è bisogno di un poliziotto esterno.
- Sanzioni graduali: Se qualcuno non rispetta le regole, non viene subito espulso. Magari prima c’è un richiamo, poi una multa leggera, e solo in caso di violazioni ripetute e gravi si arriva a sanzioni più severe.
- Risoluzione dei conflitti: Se sorgono dispute (es. un pastore pensa che un altro stia imbrogliando), c’è un meccanismo interno (un consiglio di anziani, un’assemblea) per discuterne e trovare una soluzione.
- Autonomia: La comunità ha il diritto riconosciuto di creare e far rispettare queste proprie regole, senza interferenze esterne eccessive.
Grazie a questo sistema di autogestione, i pastori riescono a preservare il pascolo per le generazioni future, garantendo la sostenibilità della risorsa e il benessere di tutti, perché le regole sono state create da loro, sono adatte alla loro realtà e vengono rispettate grazie alla fiducia e al controllo reciproco.
Questo è un esempio di come la gestione comunitaria possa essere un’alternativa efficace sia alla privatizzazione (che potrebbe escludere alcuni) sia alla gestione statale centralizzata (che potrebbe non conoscere le specificità locali).
Il bilancio partecipativo è un esempio riuscito di meccanismo ibrido che unisce competenza tecnica e volontà dei cittadini. Le esperienze di Porto Alegre, Chicago e Boston mostrano che tale pratica incrementa la spesa per sanità, servizi igienici e infrastrutture nelle aree più svantaggiate, riduce i costi amministrativi e rafforza la partecipazione civica.
Il Bilancio partecipativo…
Immagina una città, grande o piccola che sia. Tradizionalmente, il bilancio comunale (cioè come vengono spesi i soldi delle tasse per strade, scuole, parchi, servizi sociali, ecc.) viene deciso dagli amministratori e dai tecnici del comune. I cittadini votano i loro rappresentanti, ma poi la decisione su come spendere i soldi è spesso lontana dalla loro portata diretta.
Il bilancio partecipativo ribalta in parte questa logica:
- Una quota del bilancio è messa a disposizione: Il comune decide di destinare una parte del suo bilancio annuale (ad esempio, il 5% o 10% degli investimenti) a progetti scelti direttamente dai cittadini.
- I cittadini propongono idee: Vengono organizzati incontri nei quartieri, assemblee pubbliche o piattaforme online dove i cittadini possono presentare le loro idee su come spendere quei soldi. Ad esempio: “Vorremmo un nuovo parco giochi nel nostro quartiere”, “Servirebbe una pista ciclabile qui”, “Dovremmo migliorare l’illuminazione in quella strada”, “Ci vuole un centro di aggregazione per anziani”.
- Analisi tecnica e fattibilità: I tecnici del comune esaminano le proposte per verificarne la fattibilità (è realizzabile? quanto costa? ci sono permessi necessari?). A volte, le proposte vengono affinate o combinate.
- Votazione dei cittadini: Le proposte fattibili vengono poi sottoposte a una votazione diretta da parte di tutti i cittadini (o di quelli che partecipano al processo). Ogni cittadino può votare i progetti che ritiene più importanti per la sua comunità o per la città.
- Realizzazione dei progetti più votati: I progetti che ricevono più voti, fino all’esaurimento della somma messa a disposizione, vengono inclusi nel bilancio e realizzati dal comune.
In sintesi, il bilancio partecipativo è un modo per dare ai cittadini un potere decisionale diretto su una parte delle risorse pubbliche, rendendo la gestione della cosa comune più democratica, trasparente e vicina alle esigenze reali delle persone.
Le cooperative di lavoro, come la Corporazione Mondragon, dimostrano la fattibilità di modelli ibridi su larga scala. Con oltre 257 cooperative e più di 74.000 lavoratori a livello internazionale, Mondragon combina gestione democratica (“un lavoratore, un voto”), rapporti salariali contenuti (9:1 rispetto ai divari di 600:1 tipici delle grandi imprese statunitensi), fondi di solidarietà ed ecosistemi integrati che comprendono banca cooperativa, università e centri di ricerca e sviluppo.
Le piattaforme cooperative rappresentano l’evoluzione digitale di questi principi: prevedono il controllo democratico degli algoritmi di gestione, la distribuzione dei profitti tra i soci lavoratori e un’alternativa all’economia precaria di tipo estrattivo. Esperienze come Stocksy (fotografia), Resonate (musica in streaming) e CoopCycle (consegne a domicilio) dimostrano la praticabilità di piattaforme digitali di proprietà dei lavoratori.
Disegno delle strutture di potere per la governance economica democratica
La governance a rete rappresenta un’evoluzione rispetto alle strutture gerarchiche tradizionali, orientandosi verso modelli distribuiti che combinano competenza tecnica con legittimità democratica. Questo approccio riconosce che le sfide economiche contemporanee richiedono coordinamento tra attori autonomi piuttosto che un controllo centralizzato.
Governance a rete…
Immagina una città che vuole migliorare il suo sistema di trasporto pubblico. Invece di avere solo il comune che decide tutto (un approccio gerarchico tradizionale), la città adotta un modello di governance a rete.
Ecco come potrebbe funzionare:
- Attori Coinvolti (Nodi della Rete):
- Comune: Definisce gli obiettivi generali, stanzia i fondi e supervisiona.
- Azienda di Trasporto Pubblico: Gestisce gli autobus, i tram, le metropolitane.
- Associazioni di Pendolari: Rappresentano gli utenti, raccolgono feedback e propongono miglioramenti.
- Aziende Tecnologiche: Offrono soluzioni per app di biglietteria, monitoraggio in tempo reale, veicoli elettrici.
- Università/Centri di Ricerca: Forniscono studi sulla mobilità urbana, analisi dei flussi di traffico.
- Associazioni Ambientaliste: Promuovono soluzioni sostenibili e a basso impatto.
- Imprese Locali: Hanno interesse a un trasporto efficiente per i loro dipendenti e clienti.
- Come Funziona la Rete:
- Condivisione degli Obiettivi: Tutti gli attori condividono l’obiettivo comune di un trasporto pubblico efficiente, sostenibile e accessibile.
- Coordinamento e Collaborazione: Invece di ordini dall’alto, ci sono tavoli di lavoro, incontri regolari e piattaforme digitali dove tutti possono contribuire.
- Decisioni Partecipate: Le decisioni importanti (es. nuove linee, orari, tariffe, introduzione di veicoli elettrici) vengono discusse e negoziate tra i vari attori. Il comune non impone, ma facilita il consenso.
- Scambio di Conoscenze: L’azienda tecnologica condivide le sue innovazioni, l’università i suoi studi, le associazioni di pendolari il loro feedback diretto.
- Flessibilità e Adattamento: Se emerge un nuovo problema (es. traffico in una certa zona, aumento dei costi del carburante), la rete può reagire più velocemente, perché tutti sono coinvolti e possono proporre soluzioni.
In sintesi, la governance a rete è come un grande tavolo rotondo dove tutti i soggetti rilevanti si siedono insieme per risolvere un problema comune, mettendo in comune risorse, conoscenze e responsabilità, invece di aspettare che un’unica autorità decida per tutti.
I principi di progettazione per strutture di potere democratiche includono: trasparenza procedurale, standard sostantivi flessibili, capacità di adattamento, coordinamento su più livelli e inclusione significativa dei portatori di interesse. La ricerca sulla governance a rete individua tre grandi tendenze che ne accelerano la diffusione: crescita dell’esternalizzazione, passaggio verso la fornitura integrata di servizi pubblici e rivoluzione digitale che abilita la collaborazione oltre i confini nazionali.
Le assemblee cittadine e i mini-parlamenti offrono meccanismi per inserire processi di deliberazione informata nelle decisioni politiche. Secondo le analisi dell’OCSE, il loro utilizzo è in crescita per affrontare temi complessi come il cambiamento climatico o le decisioni sulle infrastrutture. Questi strumenti possono ridurre sia i costi di conformità sia i comportamenti di protesta, migliorando la legittimità delle politiche.
Il modello di governo dei portatori di interesse estende la rappresentanza democratica oltre gli azionisti, includendo lavoratori, comunità, fornitori e ambiente. Il movimento delle imprese benefit, con oltre 4.000 aziende certificate in più di 70 paesi, dimostra la fattibilità di forme di governance multi-attore anche in contesti di mercato competitivo.
La co-determinazione tedesca (Mitbestimmung), che impone la rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, offre un precedente positivo per la democratizzazione delle strutture di potere aziendali. Integrata con politiche attive del mercato del lavoro e sistemi di apprendistato, ha consentito alla Germania di mantenere la competitività manifatturiera nonostante elevati costi del lavoro.
Modello per innovazione e crescita in economie post-crescita
L’innovazione in sistemi economici ibridi deve bilanciare il progresso tecnologico con la sostenibilità ecologica e l’equità sociale. Questo richiede una ridefinizione della crescita: da semplice espansione quantitativa a sviluppo qualitativo, volto a migliorare il benessere umano entro i limiti del pianeta.
Il quadro di innovazione per economie post-crescita pone l’accento sulla circolarità piuttosto che sull’estrazione lineare. I principi dell’economia circolare includono: eliminare sprechi e inquinamento attraverso la progettazione, mantenere prodotti e materiali al loro valore più alto per il maggior tempo possibile, e rigenerare la natura tramite l’attività economica. La Fondazione Ellen MacArthur mostra come questo approccio possa disaccoppiare la crescita economica dal consumo di risorse finite.
La ricerca sulla resilienza regionale individua quattro dimensioni critiche:
- Vulnerabilità: sensibilità di imprese e lavoro agli shock.
- Resistenza: entità dell’impatto degli shock.
- Robustezza: capacità di adattarsi.
- Recuperabilità: rapidità ed estensione del processo di ripresa.
Le regioni più innovative sanno combinare diversificazione economica, forza lavoro resiliente, pianificazione preventiva contro le catastrofi e capacità di mobilitare rapidamente capitali.
I beni comuni della conoscenza e la produzione collaborativa offrono modelli scalabili per sviluppare innovazione collettiva. Progetti come Linux, Wikipedia, Arduino e altre iniziative a codice aperto dimostrano che la produzione volontaria può generare alti tassi di innovazione grazie a una collaborazione globale senza bisogno di un rigido coordinamento gerarchico.
Il modello dello Stato-partner, proposto da Michel Bauwens, suggerisce che stati e istituzioni pubbliche dovrebbero facilitare la produzione sociale autonoma fornendo infrastrutture, istruzione e quadri giuridici che valorizzino la cooperazione e la gestione dei beni comuni, piuttosto che sostituirsi a questi processi.
Il Modello dello Stato-Partner: Un Esempio Pratico
Immagina una comunità che vuole creare una piattaforma digitale per lo scambio di beni e servizi locali (ad esempio, prestare un trapano, offrire lezioni di giardinaggio, scambiare prodotti dell’orto). L’idea è che i cittadini possano collaborare e aiutarsi a vicenda, riducendo gli sprechi e rafforzando i legami sociali.
Scenario Tradizionale (Stato Interventista o Assente):
- Stato Interventista: Il comune decide di creare e gestire direttamente la piattaforma, assumendo personale, sviluppando il software e imponendo regole. Questo può essere costoso, lento e non sempre rispecchia le reali esigenze della comunità.
- Stato Assente: Il comune non fa nulla. Forse un gruppo di cittadini prova a creare la piattaforma da solo, ma incontra difficoltà legali, tecniche o di finanziamento, e il progetto fatica a decollare o a raggiungere una scala significativa.
Scenario con il Modello dello Stato-Partner:
Nel modello dello Stato-partner, il comune (lo “Stato”) non si sostituisce ai cittadini, ma agisce come un facilitatore e abilitatore.
- Fornire Infrastrutture (Digitali e Non):
- Il comune potrebbe mettere a disposizione una connessione internet ad alta velocità gratuita o a basso costo per i cittadini.
- Potrebbe offrire uno spazio fisico (es. un centro civico) dove i cittadini possono incontrarsi per organizzare il progetto o scambiare beni fisici.
- Potrebbe fornire un software open-source di base o delle linee guida tecniche per aiutare i cittadini a sviluppare la loro piattaforma, senza imporre una soluzione specifica.
- Educazione e Formazione:
- Il comune potrebbe organizzare workshop gratuiti su come usare strumenti digitali, sulla gestione di progetti collaborativi o sui principi dell’economia circolare.
- Potrebbe mettere in contatto i cittadini con esperti o università per ricevere consulenza tecnica.
- Quadri Legali e Normativi Favorevoli:
- Il comune potrebbe creare un regolamento semplice e chiaro che riconosca e supporti le iniziative di economia collaborativa, magari semplificando la burocrazia per le piccole attività di scambio.
- Potrebbe offrire consulenza legale gratuita per aiutare i cittadini a capire come gestire la privacy dei dati o le responsabilità in caso di scambi.
- Potrebbe introdurre incentivi fiscali minimi o agevolazioni per chi partecipa attivamente a queste iniziative.
- Abilitare la Cooperazione e la Gestione dei Beni Comuni:
- Invece di gestire la piattaforma, il comune incoraggia i cittadini a formare un’associazione o una cooperativa per gestirla autonomamente.
- Aiuta a definire le regole di governance della piattaforma (es. chi decide cosa, come si risolvono i conflitti) in modo partecipato, garantendo che sia un “bene comune” gestito dalla comunità stessa.
- Potrebbe offrire un piccolo finanziamento iniziale (un “seed funding”) per avviare il progetto, con l’idea che poi si auto-sostenga.
Risultato:
Con il modello dello Stato-partner, la piattaforma digitale per lo scambio locale nasce e cresce grazie all’iniziativa e alla gestione dei cittadini. Il comune non è un “capo” né “assente”, ma un alleato strategico che fornisce gli strumenti, l’ambiente e il supporto necessari affinché la comunità possa auto-organizzarsi e prosperare, creando un bene comune che risponde direttamente ai suoi bisogni.
In sintesi, lo Stato-partner non fa al posto dei cittadini, ma crea le condizioni migliori affinché i cittadini possano fare da soli, in modo collaborativo e autonomo.
Meccanismi di crisi e adattamento sistemico
I sistemi economici ibridi devono essere progettati non solo per la resilienza, ma per la capacità di diventare più forti a seguito delle crisi.
La resilienza significa tornare allo stato precedente dopo uno shock; la capacità di rafforzarsi significa invece trarre vantaggio dalla volatilità e dall’incertezza.
I principi di progettazione di sistemi che si rafforzano dalle crisi includono:
- Molteplicità di opzioni: avere diversi percorsi possibili al successo, con risultati potenzialmente sproporzionati rispetto ai rischi.
- Ridondanza: predisporre più sistemi di riserva.
- Decentramento: ridurre la dipendenza da singoli punti deboli.
- Sperimentazione su piccola scala: imparare da piccoli fallimenti per evitare catastrofi di grande portata.
- Responsabilità diretta: chi prende decisioni deve condividere anche le conseguenze delle proprie scelte.
L’adattamento richiede capacità istituzionale di evolversi in modo continuo. La ricerca di Davis mostra che la flessibilità istituzionale – cioè la capacità di creare nuove istituzioni quando servono – porta a una crescita economica più sostenibile rispetto alla staticità. I paesi con istituzioni flessibili sperimentano fasi di crescita stabile più rapide.
Le strategie proattive di gestione delle crisi includono:
- pianificazione preventiva con ruoli ben definiti per i portatori di interesse,
- diversificazione della base economica,
- rafforzamento della forza lavoro attraverso strategie fondate sulle competenze,
- capacità di mobilitare rapidamente capitale e credito in caso di interruzioni improvvise.
Infine, i sistemi di allerta precoce e i cicli di risposta rapida permettono di aggiustare rapidamente le politiche sulla base delle reazioni del sistema. Ciò richiede monitoraggio costante degli indicatori principali e meccanismi per tradurre le informazioni raccolte in aggiustamenti concreti delle politiche.
Esempio Pratico: Filiera Alimentare Locale “Anti-Fragile”
Immagina una regione che vuole costruire una filiera alimentare locale che non solo resista alle crisi (come siccità, pandemie, interruzioni delle catene di approvvigionamento globali), ma che ne esca addirittura più forte.
- Molteplicità di Opzioni (Optionality):
- Non dipendere da un’unica coltura: Invece di specializzarsi solo sul grano, la regione incoraggia la coltivazione di diverse varietà di cereali, legumi, ortaggi e frutta. Se una coltura fallisce a causa del clima, le altre possono compensare.
- Diversi canali di vendita: I produttori non vendono solo ai supermercati, ma anche direttamente ai consumatori (mercati contadini, gruppi d’acquisto), a ristoranti locali e a piccole aziende di trasformazione. Se un canale si blocca, gli altri rimangono attivi.
- Tecnologie agricole diverse: Alcuni agricoltori usano metodi tradizionali, altri agricoltura di precisione, altri ancora serre idroponiche. Questa varietà offre più soluzioni in caso di problemi specifici.
- Ridondanza (Sistemi di Backup Multipli):
- Magazzini di stoccaggio locali: Invece di affidarsi a grandi centri di distribuzione lontani, la comunità investe in piccoli magazzini e celle frigorifere distribuiti sul territorio. Se un magazzino ha un problema, gli altri possono intervenire.
- Banche dei semi locali: Creare riserve di semi di varietà autoctone e resistenti, per non dipendere solo da pochi fornitori globali.
- Reti di trasporto alternative: Oltre ai camion, sviluppare reti di consegna con veicoli elettrici più piccoli o addirittura biciclette per le consegne urbane, per ridurre la dipendenza dal carburante o dalle grandi infrastrutture stradali.
- Decentramento (Ridotta Dipendenza da Punti di Fallimento Singoli):
- Piccole aziende di trasformazione: Invece di un’unica grande fabbrica di trasformazione (es. per il pomodoro), la regione supporta diverse piccole cooperative o laboratori artigianali distribuiti. Se uno si ferma, la produzione non si blocca del tutto.
- Molteplici fonti d’acqua: Non dipendere solo da un grande acquedotto, ma anche da pozzi locali, sistemi di raccolta dell’acqua piovana e gestione sostenibile delle falde.
- Produzione energetica distribuita: Installare pannelli solari o piccole turbine eoliche nelle fattorie e nei centri di trasformazione, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica nazionale.
- Sperimentazione su Piccola Scala (Imparare dai Piccoli Fallimenti):
- Progetti pilota: Incoraggiare gli agricoltori a sperimentare nuove colture o tecniche su piccole porzioni di terreno. Se un esperimento fallisce, le perdite sono contenute, ma si impara molto.
- “Hackathon” alimentari: Organizzare eventi dove innovatori, agricoltori e cittadini propongono e testano soluzioni rapide a piccoli problemi della filiera (es. come ridurre lo spreco di un certo prodotto, come migliorare la logistica dell’ultimo miglio).
- Forum di condivisione: Creare spazi dove i produttori possono condividere apertamente i loro successi e fallimenti, imparando gli uni dagli altri.
- Responsabilità Diretta (Skin in the Game):
- Cooperative di produttori e consumatori: I membri della cooperativa (sia chi produce che chi consuma) hanno un interesse diretto nel successo della filiera e condividono rischi e benefici.
- Investimenti locali: Incoraggiare i cittadini a investire direttamente nelle aziende agricole o di trasformazione locali, allineando gli interessi finanziari con la salute della filiera.
- Trasparenza totale: I consumatori sanno esattamente da dove viene il cibo, come è stato prodotto e chi sono i produttori, creando un legame di fiducia e responsabilità reciproca.
Come la filiera diventa “anti-fragile”:
Se arriva una crisi (es. un’alluvione che distrugge una parte dei campi, o un blocco delle importazioni):
- La diversificazione (molteplicità di opzioni) fa sì che non tutto sia compromesso.
- La ridondanza permette di attivare i sistemi di riserva.
- Il decentramento evita che il fallimento di un singolo elemento paralizzi l’intero sistema.
- Le esperienze passate (sperimentazione su piccola scala) hanno già fornito lezioni preziose.
- La responsabilità diretta spinge tutti a trovare soluzioni e a collaborare per superare la difficoltà, sapendo che il loro benessere dipende da quello della filiera.
Invece di crollare, la filiera impara dalla crisi, si adatta, e magari scopre nuovi modi per produrre, distribuire o consumare, diventando più robusta e innovativa per il futuro.
Strategia di transizione dal sistema attuale
La transizione verso un sistema economico ibrido richiede una strategia graduale che operi all’interno dei quadri esistenti, espandendo progressivamente gli spazi per modelli alternativi. Questo approccio riconosce che le trasformazioni sistemiche richiedono tempo e devono costruire consenso e capacità istituzionale.
La fase uno della transizione si concentra sulla riforma dei meccanismi attuali: implementazione di un prezzo per le emissioni di carbonio tramite tasse e sistemi di scambio di quote, riforma fiscale progressiva che includa tasse sul patrimonio, rafforzamento della regolamentazione anti-monopolio ed espansione delle reti di protezione sociale, inclusi i servizi di base universali.
La fase due introduce meccanismi ibridi sperimentali: bilanci partecipativi in città e regioni, supporto per cooperative e imprese sociali, piattaforme digitali per la governance partecipativa e aree di sperimentazione per testare approcci innovativi prima dell’implementazione a livello di sistema.
La fase tre estende l’innovazione istituzionale attraverso quadri giuridici per le società benefit e la governance multi-attore, la governance a rete per il coordinamento intersettoriale, la gestione dei beni comuni per le risorse naturali e la conoscenza, e l’integrazione di indicatori post-crescita nei processi di pianificazione governativa.
La strategia di transizione deve anche affrontare i vincoli dell’economia politica. Gli interessi consolidati resisteranno ai cambiamenti che riducono la loro quota di potere e risorse. Ciò richiede la costruzione di coalizioni che dimostrino come i modelli ibridi possano beneficiare ampi segmenti della popolazione, inclusi piccole imprese, lavoratori e comunità locali.
L’educazione e lo sviluppo delle capacità sono essenziali per acquisire le competenze necessarie per la governance partecipativa e la gestione cooperativa. Questo include l’alfabetizzazione finanziaria, le competenze deliberative, la comprensione dei sistemi complessi e la leadership collaborativa.
Stress testing e modalità di fallimento del modello ibrido
Ogni sistema economico presenta potenziali modalità di fallimento che devono essere identificate e mitigate attraverso una progettazione intelligente. Il modello ibrido proposto non è immune da questi rischi e richiede meccanismi di monitoraggio e correzione continui.
Primo rischio: complessità della governance.
Sistemi che combinano mercato, democrazia partecipativa e gestione dei beni comuni possono soffrire di paralisi decisionale o di conflitti tra i diversi meccanismi allocativi. La mitigazione richiede:
- confini chiari tra i diversi strumenti di allocazione,
- procedure per la risoluzione dei conflitti,
- criteri ordinatori condivisi quando emergono scelte difficili da bilanciare.
Secondo rischio: opportunismo nella partecipazione.
Nelle strutture partecipative, se la partecipazione democratica richiede troppo tempo ed energie, molti cittadini potrebbero scegliere di astenersi, lasciando il potere decisionale a minoranze ben organizzate. Per ridurre questo rischio sono utili:
- incentivi alla partecipazione,
- rotazione delle responsabilità,
- combinazione di strumenti deliberativi con elementi di rappresentanza.
Terzo rischio: cattura regolatoria da parte di interessi forti.
Anche sistemi costruiti per l’inclusione democratica possono essere manipolati da gruppi con risorse economiche e capacità organizzativa superiori. Le protezioni efficaci includono:
- requisiti di trasparenza,
- regole per la gestione dei conflitti di interesse,
- meccanismi di controllo e vigilanza da parte dei cittadini.
Valutazione del modello.
Per verificare la solidità del modello occorrono indicatori multidimensionali, oltre alle metriche economiche tradizionali:
- indici di benessere,
- misure di sostenibilità ecologica,
- livelli di fiducia sociale,
- qualità della governance democratica,
- resilienza agli shock economici.
La validazione empirica del modello deve includere:
- sperimentazioni su scala ridotta,
- osservazione di esperienze reali in contesti che hanno adottato elementi ibridi,
- simulazioni di sistemi complessi per studiare le interazioni tra componenti diverse.
Integrazione finale: verso un sistema economico adattivo e sostenibile
Il sistema economico ibrido per il ventunesimo secolo rappresenta una sintesi che cerca di superare i limiti tanto del capitalismo quanto del socialismo, integrandone i punti di forza e mitigandone le debolezze strutturali. Non si tratta di un compromesso statico, ma di un quadro adattivo, capace di evolvere e rispondere a condizioni mutevoli.
La struttura sistemica combina:
- la capacità informativa e di stimolo dei mercati,
- la legittimità democratica e l’orientamento di lungo periodo della governance partecipativa,
- l’operare entro i limiti ecologici che definiscono la sostenibilità del pianeta.
Questa integrazione richiede un disegno istituzionale sofisticato, capace di gestire le tensioni tra efficienza, equità e sostenibilità.
Il principio operativo centrale è la diversità istituzionale, piuttosto che l’ottimizzazione secondo un unico criterio. Come accade negli ecosistemi naturali, la stabilità del sistema nasce dalla coesistenza di approcci molteplici, che si rinforzano a vicenda e garantiscono ridondanza quando singole componenti falliscono.
La governance adattiva permette un apprendimento continuo e aggiustamenti basati su evidenze empiriche, anziché su un impegno ideologico verso modelli teorici rigidi. Ciò richiede:
- umiltà intellettuale,
- apertura alla sperimentazione,
- disponibilità a modificare gli approcci quando le prove suggeriscono miglioramenti.
Il modello riconosce che gli esseri umani sono al tempo stesso individui e membri di collettività, capaci di cooperazione come di competizione. Piuttosto che assumere una “natura umana” fissa, il sistema crea condizioni istituzionali che incanalano queste tendenze verso risultati che giovano sia ai singoli sia alle comunità.
L’implementazione pratica deve procedere tramite:
- sperimentazioni diffuse,
- apprendimento condiviso,
- espansione graduale delle pratiche di successo.
Questo consente di adattarsi ai contesti locali e, al tempo stesso, di costruire una conoscenza più profonda su quali meccanismi funzionino in condizioni diverse.
Il futuro economico richiederà un’evoluzione continua, non l’adozione di un modello definitivo. Il sistema ibrido proposto offre una base per tale evoluzione: unisce principi stabili (partecipazione democratica, sostenibilità ecologica, benessere umano) a una flessibilità istituzionale che consente l’adattamento alle sfide emergenti del ventunesimo secolo.
Questa visione non è utopica ma pragmatica: riconosce i vincoli della natura umana e dei sistemi naturali, esplorando al tempo stesso le possibilità di un disegno istituzionale creativo capace di ampliare lo spazio delle soluzioni. Il cammino richiede tanto analisi rigorosa quanto coraggio sperimentale, costruendo ponti tra ciò che esiste oggi e ciò che potrebbe esistere domani.
Riferimenti e Fonti
Economia comportamentale e cooperazione umana
- Fehr, E., & Gintis, H. (2007). Human motivation and social cooperation: Experimental and analytical foundations. Annual Review of Sociology, 33(1), 43–64. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.040406.131812
- Fehr, E., & Schmidt, K. M. (1999). A theory of fairness, competition, and cooperation. The Quarterly Journal of Economics, 114(3), 817–868. https://doi.org/10.1162/003355399556151
- Bowles, S., & Gintis, H. (2011). A cooperative species: Human reciprocity and its evolution. Princeton University Press.
Fallimenti sistemici del capitalismo
- Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E. (2016). The euro: How a common currency threatens the future of Europe. W. W. Norton.
- OECD. (2019). Under pressure: The squeezed middle class. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/689afed1-en
Modelli economici ibridi
- Restakis, J. (2010). Humanizing the economy: Co-operatives in the age of capital. New Society Publishers.
- Wright, E. O. (2010). Envisioning real utopias. Verso.
- International Cooperative Alliance, & Euricse. (2020). World cooperative monitor 2020: Exploring the cooperative economy. Euricse/ICA.
Economia post-crescita
- Daly, H. E. (2014). From uneconomic growth to a steady-state economy. Edward Elgar.
- Jackson, T. (2017). Prosperity without growth: Foundations for the economy of tomorrow (2ª ed.). Routledge.
- Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing.
Governance partecipativa
- Fung, A., & Wright, E. O. (Eds.). (2003). Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. Verso.
- Baiocchi, G., & Ganuza, E. (2016). Popular democracy: The paradox of participation. Princeton University Press.
- OECD. (2020). Innovative citizen participation and new democratic institutions. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/339306da-en
Commons e gestione delle risorse
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
- Bollier, D., & Helfrich, S. (Eds.). (2015). Patterns of commoning. Levellers Press.
- New Economics Foundation. (2019). Commoning economy: A self-organising future.
Sistemi complessi e resilienza
- Taleb, N. N. (2012). Antifragile: Things that gain from disorder. Random House.
- Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography, 15(1), 1–42. https://doi.org/10.1093/jeg/lbu015
- Davis, L. E., & North, D. C. (1971). Institutional change and American economic growth. Cambridge University Press.
Economia circolare
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. Ellen MacArthur Foundation.
- European Commission. (2020). Circular economy action plan. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/05068
Reddito di base universale
- Standing, G. (2017). Basic income: And how we can make it happen. Pelican Books.
- Egger, D., Haushofer, J., Miguel, E., Niehaus, P., Robinson, J., Roll, S., … & Walker, M. (2022). General equilibrium effects of cash transfers: Experimental evidence from Kenya. The Quarterly Journal of Economics, 137(4), 2293–2361. https://doi.org/10.1093/qje/qjac020
Cooperative economiche
- Mondragon Corporation. (2019). Annual report. Mondragon Corporation.
- Birchall, J., & Hammond Ketilson, L. (2009). Resilience of the cooperative business model in times of crisis. International Labour Organization.